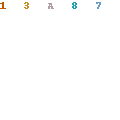31 gennaio, 2011
27 gennaio, 2011
Cose serie, fatiche politiche. E una segnalazione
 Mentre nel mondo continuano a succedere cose serie, anche non lontano da casa nostra e che chiamano a interrogarsi su cosa significa, per il nostro Mezzogiorno, una rivolta di giovani senza futuro, che esplode sulla sponda meridionale del Mar Mediterraneo… e mentre molto seriamente riprende la via crucis monnezza nella ben più prossima cittadina di Quarto…
Mentre nel mondo continuano a succedere cose serie, anche non lontano da casa nostra e che chiamano a interrogarsi su cosa significa, per il nostro Mezzogiorno, una rivolta di giovani senza futuro, che esplode sulla sponda meridionale del Mar Mediterraneo… e mentre molto seriamente riprende la via crucis monnezza nella ben più prossima cittadina di Quarto…… Beh, invece qui da noi c’è il solito andazzo dei quaquaraquà – come direbbe il buon principe De Curtis. Che, tuttavia, è ulteriore, perenne indizio delle fatiche di fare buona politica da queste parti.
L’assemblea nazionale del Pd – di cui sono membro – convocata a Napoli per domani e dopodomani aveva all’ordine del giorno le questioni della sicurezza e della lotta alla criminalità come questioni di diritti, anche. E’ un tassello di una maratona, che dura da sei mesi, tesa a mettere a punto il programma di merito, il cosa si farebbe se ci fosse un altro governo, il cosa serve all’Italia. Che, nel bene e nel male, il Pd, anche nell’ultima assemblea tenuta a Varese tenta di fare. Certo, sono cose che non hanno sciolto le confusioni interne ma che certamente danno un numero maggiore di indicazioni di merito rispetto a altri soggetti politici dell’opposizione.
Ma ieri l’assemblea è stata annullata e rimandata su richiesta di Bersan, in seguito alla vicenda napoletana sulla quale ho commentato due giorni fa su l’Unità, ripresa in vari siti e giornali.
Con il casino che è successo nelle ultime quarantotto ore a Napoli, in effetti, intanto bisognerebbe seriamente chiedere scusa; e, solo dopo, si poteva proporre di fare due sole cose. O rimandare e poi si vede. Come si è fatto. E speriamo che ciò porti a un nuovo inizio e a non annullare la parte positiva dell’afflusso alle primarie e i residui di speranza e ri-attivazione politica sana a Napoli. Anche se – detto francamente e visto il clima di forte disillusione – sarà difficile.
Oppure si poteva tenerla l’assemblea, con un momento che l’anticipava, però. Nel quale il segretario nazionale del partito, senza rimozioni né prudenze, veniva giù e faceva un discorso alto sulla difficoltà di fare politica nel Sud, chiedeva ai quattro candidati di rinunciare a ogni pretesa, diceva alla commissione di accertare la verità e chiamava ad una assise napoletana della speranza politica, aperta davvero alla società civile – quella vera - e a un possibile programma civile di rinascita della città. Un approccio che, in ogni caso, potrebbe favorire, anche se lo si fa tra qualche giorno, il rilancio di una candidatura nuova (tutte quelle avute ormai appaiono fatalmente compromesse). Se è questo l’intento e il passaggio necessario per non perdere la città alla destra.
Il Pd può ancora farlo, certo. E speriamo che accada. Va, infatti, recuperato ogni slancio e punita ogni vecchia politica. Ma l’impressione è di grande confusione, di eterno nascondere la gravità dello stato della politica in città e del disastroso conflitto interno al pd e della sua miserevole gestione.
Oggi, però – lo voglio ricordare anche in virtù del tanto lavoro comune fatto con l’Associazione 27 gennaio - è anche il giorno della memoria. La memoria e la sua difficile “tenuta” è tema faticosamente aperto. E, a tale proposito segnalo queste due recensioni al libro Parole chiare, del quale sono co-autore, con un capitolo sulla Risiera di San Saba a Trieste, luogo da me visitato e raccontato.
Le foto della Risiera stavolta sono mie
25 gennaio, 2011
Chiarire subito
Tutta la stampa nazionale sottolinea i molti punti oscuri della vittoria di misura alle primarie di Cozzolino. Oggi è uscito un mio pezzo in prima pagina su l'Unità con cui cerco di capire. Lo riporto qui.
Ieri alle primarie napoletane per il candidato sindaco del centro-sinistra hanno partecipato 44 mila persone. Una cosa immensa. Diecimila in più di quelle che votarono per le primarie di Prodi. Quasi il doppio di Milano.
Faceva freddo. La neve copriva il Vesuvio fin giù. Eppure c’erano file di cittadini pazienti, in ogni seggio e fino a tardi.
C’è – in questo afflusso inatteso – il segno di più cose. Alcune buone. Che dovremmo nutrire con grande cura e costanza. Altre cattive. Che dovremmo guardare in modo radicalmente impietoso. Per mettervi mano e subito.
C’è di buono che una parte dell’elettorato di centro-sinistra si è mobilitato. E lo ha fatto nonostante tutto. Nonostante vi sia una grande delusione per i risultati del governo cittadino. Nonostante il centro-sinistra si sia troppo occupato, negli anni, di contese tra posizioni di rendita non giustificate dal merito e di personalismi esasperati anziché di analisi e di proposte. E nonostante vi sia stato un solo confronto tra i candidati.
Così, una parte dell’elettorato di centro-sinistra è restata a casa, “percossa e inaridita”. Ma un’altra ha sentito che la situazione oggi chiama tutti a un sussulto di impegno. E si è mobilitata sospinta dall’indignazione verso Berlusconi ma anche intorno ai temi veri. Mancanza di lavoro. Nessun sostegno alle famiglie. Attacco al welfare e all’esercito civile che si occupa delle fragilità e delle ingiustizie sociali. Scuole senza mezzi. Cantieri e industrie fermi. Periferie abbandonate. Falso federalismo, che annulla ogni perequazione.
I cittadini di Napoli vivono ancora più degli altri queste cose sulla propria pelle. E la consapevolezza di una condizione che si va facendo intollerabile ha mobilitato le parti sane dei quartieri popolari. Che si erano attivate intorno alla vicenda dei rifiuti o dell’acqua pubblica o del movimento “il welfare non è un lusso”. E una parte di chi si è attivato è andata anche a votare. E, insieme, è andata a votare una parte della Napoli più protetta e impegnata civilmente. E lo ha fatto – lo si sente nel parlare diffuso di queste ore - anche per dare un ultimo segnale: “la pazienza non è infinita, siamo qui ma cambiate registro, cambiate facce, cambiate metodi!”
Ma, purtroppo, queste ore ci stanno rivelando che, nel voto di domenica, c’è stato anche altro: migliaia di persone sono state chiamate a votare perché inquadrate dai mediatori che manovrano i “pacchetti di voti”. I quali portano ai seggi persone che non votano da cittadini. C’è, infatti, nella pieghe dell’esclusione sociale di massa, un esercito potenziale che vota in cambio di promesse e favori o di piccoli tornaconti immediati. E’ triste, ma vale la pena nominarli. Brevi lavori e inserimento in liste di disoccupati ai quali verrà promesso lavoro o corsi di formazione. Piccoli favori e facilitazioni burocratiche. Contatti per il permesso di soggiorno. Giornate pagate per l’affissione di manifesti e il porta a porta. Ma anche la ricarica di un cellulare, il biglietto della partita, un pagamento enel, l’annullamento di una multa, qualche banconota. Chi ha vissuto e lavorato nei quartieri difficili conosce a memoria i gesti, i modi, le regole non scritte di tutto questo. E domenica, purtroppo, le ha riviste all’opera. Ha visto arrivare ai seggi gruppi accompagnati da un capo che chiede, indica, controlla, verifica. Non ovunque. In qualche luogo si è trattato di minoranze. In altri no. In taluni seggi sono stati riversati una quantità di voti alle primarie maggiore dell’insieme del voto al Pd delle ultime regionali.
Così – sullo sfondo di una città sospesa tra faticosa ripresa di impegno e nuova disillusione – questa seconda parte del voto pone una grande questione politica e di etica civile. Di fronte ai ricorsi motivati che sono subito giunti ai garanti, non può durare a lungo la polemica. Il merito del contendere va affrontato. In particolare chi ha vinto – che ricopre ovviamente una speciale responsabilità – non può minimizzare le accuse di irregolarità provenienti da più parti. E deve subito rispondere vicenda per vicenda, seggio per seggio. Lo richiede non solo la sua credibilità di candidato ma quella di tutto lo schieramento di centro-sinistra. Lo chiede l’urgenza dell’innovazione politica a Napoli. Lo chiede – ben più oltre - l’attesa più generale di chi intende battersi contro questa destra, anche fuori da Napoli. Perché ovunque in Italia sentiamo che ciò che rende meno credibile la battaglia alla quale ci stiamo preparando va rimosso. Altrimenti veniamo smentiti in quel che diciamo di essere e di voler fare. E non ce lo possiamo proprio più permettere.
Ieri alle primarie napoletane per il candidato sindaco del centro-sinistra hanno partecipato 44 mila persone. Una cosa immensa. Diecimila in più di quelle che votarono per le primarie di Prodi. Quasi il doppio di Milano.
Faceva freddo. La neve copriva il Vesuvio fin giù. Eppure c’erano file di cittadini pazienti, in ogni seggio e fino a tardi.
C’è – in questo afflusso inatteso – il segno di più cose. Alcune buone. Che dovremmo nutrire con grande cura e costanza. Altre cattive. Che dovremmo guardare in modo radicalmente impietoso. Per mettervi mano e subito.
C’è di buono che una parte dell’elettorato di centro-sinistra si è mobilitato. E lo ha fatto nonostante tutto. Nonostante vi sia una grande delusione per i risultati del governo cittadino. Nonostante il centro-sinistra si sia troppo occupato, negli anni, di contese tra posizioni di rendita non giustificate dal merito e di personalismi esasperati anziché di analisi e di proposte. E nonostante vi sia stato un solo confronto tra i candidati.
Così, una parte dell’elettorato di centro-sinistra è restata a casa, “percossa e inaridita”. Ma un’altra ha sentito che la situazione oggi chiama tutti a un sussulto di impegno. E si è mobilitata sospinta dall’indignazione verso Berlusconi ma anche intorno ai temi veri. Mancanza di lavoro. Nessun sostegno alle famiglie. Attacco al welfare e all’esercito civile che si occupa delle fragilità e delle ingiustizie sociali. Scuole senza mezzi. Cantieri e industrie fermi. Periferie abbandonate. Falso federalismo, che annulla ogni perequazione.
I cittadini di Napoli vivono ancora più degli altri queste cose sulla propria pelle. E la consapevolezza di una condizione che si va facendo intollerabile ha mobilitato le parti sane dei quartieri popolari. Che si erano attivate intorno alla vicenda dei rifiuti o dell’acqua pubblica o del movimento “il welfare non è un lusso”. E una parte di chi si è attivato è andata anche a votare. E, insieme, è andata a votare una parte della Napoli più protetta e impegnata civilmente. E lo ha fatto – lo si sente nel parlare diffuso di queste ore - anche per dare un ultimo segnale: “la pazienza non è infinita, siamo qui ma cambiate registro, cambiate facce, cambiate metodi!”
Ma, purtroppo, queste ore ci stanno rivelando che, nel voto di domenica, c’è stato anche altro: migliaia di persone sono state chiamate a votare perché inquadrate dai mediatori che manovrano i “pacchetti di voti”. I quali portano ai seggi persone che non votano da cittadini. C’è, infatti, nella pieghe dell’esclusione sociale di massa, un esercito potenziale che vota in cambio di promesse e favori o di piccoli tornaconti immediati. E’ triste, ma vale la pena nominarli. Brevi lavori e inserimento in liste di disoccupati ai quali verrà promesso lavoro o corsi di formazione. Piccoli favori e facilitazioni burocratiche. Contatti per il permesso di soggiorno. Giornate pagate per l’affissione di manifesti e il porta a porta. Ma anche la ricarica di un cellulare, il biglietto della partita, un pagamento enel, l’annullamento di una multa, qualche banconota. Chi ha vissuto e lavorato nei quartieri difficili conosce a memoria i gesti, i modi, le regole non scritte di tutto questo. E domenica, purtroppo, le ha riviste all’opera. Ha visto arrivare ai seggi gruppi accompagnati da un capo che chiede, indica, controlla, verifica. Non ovunque. In qualche luogo si è trattato di minoranze. In altri no. In taluni seggi sono stati riversati una quantità di voti alle primarie maggiore dell’insieme del voto al Pd delle ultime regionali.
Così – sullo sfondo di una città sospesa tra faticosa ripresa di impegno e nuova disillusione – questa seconda parte del voto pone una grande questione politica e di etica civile. Di fronte ai ricorsi motivati che sono subito giunti ai garanti, non può durare a lungo la polemica. Il merito del contendere va affrontato. In particolare chi ha vinto – che ricopre ovviamente una speciale responsabilità – non può minimizzare le accuse di irregolarità provenienti da più parti. E deve subito rispondere vicenda per vicenda, seggio per seggio. Lo richiede non solo la sua credibilità di candidato ma quella di tutto lo schieramento di centro-sinistra. Lo chiede l’urgenza dell’innovazione politica a Napoli. Lo chiede – ben più oltre - l’attesa più generale di chi intende battersi contro questa destra, anche fuori da Napoli. Perché ovunque in Italia sentiamo che ciò che rende meno credibile la battaglia alla quale ci stiamo preparando va rimosso. Altrimenti veniamo smentiti in quel che diciamo di essere e di voler fare. E non ce lo possiamo proprio più permettere.
24 gennaio, 2011
Col passato non si riesce proprio a rompere
Ritorno qui dopo qualche settimana di assenza, dovuta soprattutto a un vero imbuto di lavori da terminare. E me ne scuso. Avrei dovuto scrivere di cose importanti. Non solo Berlusca e i suoi molti significati, anche in termini di educazione civile (sic!) ma la Tunisia, l’Albania, cose che ci riguardano eccome, noi di qui, con i giovani senza lavoro né studio…
Ma poi c’è Napoli.
Sabato, prima del voto, ho scritto un articolo per Repubblica Napoli che riporto integralmente qui sotto, titolato: cosa significa rompere col passato. Avevo indicato – entro un quadro di vera desertificazione politica – una piccola possibilità di tenere la speranza aperta, riguardo alla rappresentanza, nel voto a Umberto Ranieri. Ma avevo parlato sostanzialmente del perché dello stato pietoso di vuoto politico nel quale vive da troppo tempo la città.
Questa sostanza, anche molto triste, del mio ragionamento viene drammaticamente confermata dai fatti del voto di domenica. Al di là della vittoria di misura di Cozzolino, al di là anche della vergogna dei brogli o delle promesse di posti in una città disperata o dei voti contro vil denaro – tutte cose avvenute sotto i nostri occhi – le truppe cammellate delle fazioni più conservatrici e chiuse al cambiamento del Pd, fondate su basi di fedeltà ai capuzzielli, proprio come scrivevo, hanno avuto il peso maggiore e imposto il timbro a queste primarie. E ciò nonostante un afflusso molto variegato e anche ricco. Insomma ancora una volta 'a politica – quella cosa lì - con i suoi modi, mostra, appunto, che a Napoli fa fatica a vincere la proposta, il procedere democratico, il rispetto vero per la rappresentanza, lo sguardo teso alla partecipazione che sia autentico, che si interroghi.
I brogli annunciati, denunciati in tempo reale fin da ieri mattina, visti da tanti amici testimoni – che sono stati l’ennesima copia di quel che avvenne per le primarie del pd del 2007, per chi vuole serbare sana memoria – hanno, inoltre, offeso la testarda partecipazione civile di tanti e tante cittadini. Che nonostante tutto hanno voluto mostrare alla brutta politica della città che cambiare si può. Infatti 44 mila votanti, con tante e tante brave persone in fila ai seggi, hanno raccolto anche la sfida dei tempi, la sfida di cambiare pagina, battere la destra ma cambiando questo centro-sinistra di Napoli. Ma è prevalsa una vittoria del passato, che divide, con in più questa macchia nera, brutta, indelebile. E che rende la divisione nel centro-sinistra una cosa ancor più grave e difficile da gestire di quello che già era.
Nei giorni prossimi rivedremo le brutte polemiche, la conta dei voti, il loro ritiro…
Non ce la facciamo più, è un disco incantato, già sentito. La politica gira a vuoto. E mostra irresponsabilità, pochezza, miserie. Meritiamo altro in Italia e altro a Napoli.
Nonostante un vero sfinimento dovremo reagire. Ma come? C’è tanto da pensare, siamo tornati alla casella di partenza.
Quello che segue è l'articolo su la Repubblica Napoli di sabato 22 gennaio 2011.
Che cosa significa rompere col passato
Domenica le primarie del centro-sinistra stabiliranno chi sarà il candidato sindaco di Napoli.
Da dove partire per decidere se e per chi votare? Dalla constatazione, triste, del vuoto politico in cui questa città vive. E’ un vuoto grandissimo. Che ha quattro cause, tra loro strettamente connesse.
La prima è strutturale e politica insieme. Il Mezzogiorno paga più duramente questa crisi globale. Perché ha tutti gli indicatori economici e sociali ben più in rosso di quelli del nord, che pure sono peggiorati. Risollevarsi da un baratro più profondo richiede mezzi maggiori. Ma le risorse non ci sono e, inoltre, è prevalsa la scelta politica contraria: il centro-destra, sospinto dalla lega, ha regolarmente drenato risorse verso il nord annullando ogni idea perequativa di federalismo. Inoltre, nel farlo, ha impedito qualsiasi valutazione di politica economica che considerasse i riequilibri planetari che stanno, dopo cinquecento anni, riaprendo i flussi di mercato tra occidente e oriente, che attraversano nuovamente il Mediterraneo e potrebbero sollecitare un nuovo sviluppo per il Sud, pensato in modo diverso che in passato.
La seconda è data dalla cultura politica che ha dominato la città. E bene ha fatto, ieri, Ottavio Ragone a ricostruire, con serena severità, questa nostra vicenda. Che, nelle amministrazioni di Napoli, ha visto prevalere le diverse anime della cultura legata alla storia del PCI e ai suoi seguiti. Per ben venticinque anni su trentacinque. Si è trattato di una cultura politica che ha certamente avuto momenti nobili e meriti. Ma che è stata tenacemente centralistica, fondata sul controllo e legata all’idea di capo, di gruppo dirigente chiuso che coopta secondo criteri di fedeltà e non di merito. Una cultura fondata sull’idea di nemico esterno da battere, di spesa pubblica contrapposta all’iniziativa privata salvo quando questa porta con sé fedeltà politica. E sull’idea di pianificazione intesa come gabbia che regola rigidamente e non come ispiratrice dell’azione multiforme negli spazi e nei tempi della città, salvo poi non riuscirci e permettere ogni cosa, senza confronto libero e criteri di valutazione ragionevoli, come, invece, accade altrove nel mondo. Si è trattato di una cultura sostanzialmente conservatrice, che ha sempre privilegiato le scelte dall’alto verso il basso ignorando o boicottando le procedure decisionali basate su pratiche partecipative e deliberazioni diffuse. Che ha ripeuto una concezione di spazio pubblico illiberale e povero. Perché incapace di osservare e sostenere le esperienze che nascono da sole e promettono soluzioni proficue. Perché rivolta alle forze organizzate più che alle aggregazioni intorno a bisogni e esperienze. Perché sospettosa di qualsiasi comunità che privilegi il confronto aperto, l’iniziativa diretta, il fare nel merito, l’azione decentrata. Col tempo, messi ai margini gli esponenti migliori di questa cultura, irrisi e schiacciati volta dopo volta le nuove promesse di altre culture - di sinistra socialista o liberale o autenticamente ecologista o solidaristica o ispirata dal meridionalismo moderno - il cosiddetto personale politico si è chiuso nelle ripicche e negli asti, ha smesso di vedere la città, non ha trovato la via per esprimere altro da se stesso. Questo ha a sua volta confortato ogni compromesso con l’esistente e allevato un piccolo esercito di mestieranti del consenso e delle clientele, lontani da ispirazioni fondate sull’interesse comune, spesso capaci di tutto ma buoni a poco. Con rare eccezioni.
La terza sta nel fallimento dell’amministrazione comunale uscente, che è davanti a tutti i cittadini, senza possibilità di essere smentita; e nell’ulteriore incapacità di analizzarne pubblicamente le ragioni da parte dei responsabili e delle forze politiche.
La quarta causa sta nella pochezza dell’opposizione di centro-destra, che non ha mai espresso né cultura di governo che non fosse clientelare e improvvisata né vera opposizione ma che ha vivacchiato di piccole co-gestioni e alzate di scudo strumentali. Chi oggi sostiene che l’alternanza naturale tra le parti suggerisce di votare a destra non tiene conto di questa sua evidente nullità.
Questo gigantesco vuoto politico va oggi colmato. Ma ciò implica dire cosa si intende fare e come su lotta alla criminalità, ripresa delle produzioni, gestione differenziata dei rifiuti, valorizzazione delle periferie, dismissione dei baracconi politico-burocratici, sostegno alla partecipazione reale, rilancio dei diritti delle persone e sostegno alle politiche sociali - che sono state attaccate in modo violentissimo, lasciando la città divisa in due ancor più di prima.
Ma la campagna delle primarie ha largamente eluso il cosa fare e come. I programmi non sono stati costruiti in modo partecipativo e sono molto poveri e i candidati si sono confrontati una sola volta. Se paragonata con quella di Milano, è stata davvero poca cosa. Tanto che, in questi mesi, l’avvenimento politico più importante della città è stata la campagna di lotte il “welfare non è un lusso”.
Ma domani si vota. E la domanda - per quelli che intendono comunque votare, perché è un’occasione che in tanti abbiamo voluto – è chi sostenere e perché? La risposta la si deve faticosamente cercare per esclusione. Chi sono, tra i candidati, quelli meno prossimi, per ruolo e storia recenti, alle diverse cause della condizione disastrosa della città e del centro-sinistra? Probabilmente Mancuso e Ranieri. Ma mentre il primo, nel presentarsi, non ha voluto parlare del disastro del centro-sinistra, rivolgendo, lo sguardo esclusivamente all’avversario di destra con il solito adagio del “nemico alle porte”, foriero di tante rimozioni ed errori, il secondo, negli anni, ha almeno avvertito che il disastro era alle porte per cause interne, inascoltato.
Resta un auspicio. Che chiunque vinca, sappia davvero rompere col passato e andare subito al merito delle cose da fare. E sappia farsi aiutare veramente da una squadra ricca di competenze, di nuova cultura politica, di visi, lessico e stili cambiati, di metodo di confronto costante coi cittadini. Una squadra di donne e uomini che sappia innanzitutto ascoltare la città esclusa.
Ma poi c’è Napoli.
Sabato, prima del voto, ho scritto un articolo per Repubblica Napoli che riporto integralmente qui sotto, titolato: cosa significa rompere col passato. Avevo indicato – entro un quadro di vera desertificazione politica – una piccola possibilità di tenere la speranza aperta, riguardo alla rappresentanza, nel voto a Umberto Ranieri. Ma avevo parlato sostanzialmente del perché dello stato pietoso di vuoto politico nel quale vive da troppo tempo la città.
Questa sostanza, anche molto triste, del mio ragionamento viene drammaticamente confermata dai fatti del voto di domenica. Al di là della vittoria di misura di Cozzolino, al di là anche della vergogna dei brogli o delle promesse di posti in una città disperata o dei voti contro vil denaro – tutte cose avvenute sotto i nostri occhi – le truppe cammellate delle fazioni più conservatrici e chiuse al cambiamento del Pd, fondate su basi di fedeltà ai capuzzielli, proprio come scrivevo, hanno avuto il peso maggiore e imposto il timbro a queste primarie. E ciò nonostante un afflusso molto variegato e anche ricco. Insomma ancora una volta 'a politica – quella cosa lì - con i suoi modi, mostra, appunto, che a Napoli fa fatica a vincere la proposta, il procedere democratico, il rispetto vero per la rappresentanza, lo sguardo teso alla partecipazione che sia autentico, che si interroghi.
I brogli annunciati, denunciati in tempo reale fin da ieri mattina, visti da tanti amici testimoni – che sono stati l’ennesima copia di quel che avvenne per le primarie del pd del 2007, per chi vuole serbare sana memoria – hanno, inoltre, offeso la testarda partecipazione civile di tanti e tante cittadini. Che nonostante tutto hanno voluto mostrare alla brutta politica della città che cambiare si può. Infatti 44 mila votanti, con tante e tante brave persone in fila ai seggi, hanno raccolto anche la sfida dei tempi, la sfida di cambiare pagina, battere la destra ma cambiando questo centro-sinistra di Napoli. Ma è prevalsa una vittoria del passato, che divide, con in più questa macchia nera, brutta, indelebile. E che rende la divisione nel centro-sinistra una cosa ancor più grave e difficile da gestire di quello che già era.
Nei giorni prossimi rivedremo le brutte polemiche, la conta dei voti, il loro ritiro…
Non ce la facciamo più, è un disco incantato, già sentito. La politica gira a vuoto. E mostra irresponsabilità, pochezza, miserie. Meritiamo altro in Italia e altro a Napoli.
Nonostante un vero sfinimento dovremo reagire. Ma come? C’è tanto da pensare, siamo tornati alla casella di partenza.
Quello che segue è l'articolo su la Repubblica Napoli di sabato 22 gennaio 2011.
Che cosa significa rompere col passato
Domenica le primarie del centro-sinistra stabiliranno chi sarà il candidato sindaco di Napoli.
Da dove partire per decidere se e per chi votare? Dalla constatazione, triste, del vuoto politico in cui questa città vive. E’ un vuoto grandissimo. Che ha quattro cause, tra loro strettamente connesse.
La prima è strutturale e politica insieme. Il Mezzogiorno paga più duramente questa crisi globale. Perché ha tutti gli indicatori economici e sociali ben più in rosso di quelli del nord, che pure sono peggiorati. Risollevarsi da un baratro più profondo richiede mezzi maggiori. Ma le risorse non ci sono e, inoltre, è prevalsa la scelta politica contraria: il centro-destra, sospinto dalla lega, ha regolarmente drenato risorse verso il nord annullando ogni idea perequativa di federalismo. Inoltre, nel farlo, ha impedito qualsiasi valutazione di politica economica che considerasse i riequilibri planetari che stanno, dopo cinquecento anni, riaprendo i flussi di mercato tra occidente e oriente, che attraversano nuovamente il Mediterraneo e potrebbero sollecitare un nuovo sviluppo per il Sud, pensato in modo diverso che in passato.
La seconda è data dalla cultura politica che ha dominato la città. E bene ha fatto, ieri, Ottavio Ragone a ricostruire, con serena severità, questa nostra vicenda. Che, nelle amministrazioni di Napoli, ha visto prevalere le diverse anime della cultura legata alla storia del PCI e ai suoi seguiti. Per ben venticinque anni su trentacinque. Si è trattato di una cultura politica che ha certamente avuto momenti nobili e meriti. Ma che è stata tenacemente centralistica, fondata sul controllo e legata all’idea di capo, di gruppo dirigente chiuso che coopta secondo criteri di fedeltà e non di merito. Una cultura fondata sull’idea di nemico esterno da battere, di spesa pubblica contrapposta all’iniziativa privata salvo quando questa porta con sé fedeltà politica. E sull’idea di pianificazione intesa come gabbia che regola rigidamente e non come ispiratrice dell’azione multiforme negli spazi e nei tempi della città, salvo poi non riuscirci e permettere ogni cosa, senza confronto libero e criteri di valutazione ragionevoli, come, invece, accade altrove nel mondo. Si è trattato di una cultura sostanzialmente conservatrice, che ha sempre privilegiato le scelte dall’alto verso il basso ignorando o boicottando le procedure decisionali basate su pratiche partecipative e deliberazioni diffuse. Che ha ripeuto una concezione di spazio pubblico illiberale e povero. Perché incapace di osservare e sostenere le esperienze che nascono da sole e promettono soluzioni proficue. Perché rivolta alle forze organizzate più che alle aggregazioni intorno a bisogni e esperienze. Perché sospettosa di qualsiasi comunità che privilegi il confronto aperto, l’iniziativa diretta, il fare nel merito, l’azione decentrata. Col tempo, messi ai margini gli esponenti migliori di questa cultura, irrisi e schiacciati volta dopo volta le nuove promesse di altre culture - di sinistra socialista o liberale o autenticamente ecologista o solidaristica o ispirata dal meridionalismo moderno - il cosiddetto personale politico si è chiuso nelle ripicche e negli asti, ha smesso di vedere la città, non ha trovato la via per esprimere altro da se stesso. Questo ha a sua volta confortato ogni compromesso con l’esistente e allevato un piccolo esercito di mestieranti del consenso e delle clientele, lontani da ispirazioni fondate sull’interesse comune, spesso capaci di tutto ma buoni a poco. Con rare eccezioni.
La terza sta nel fallimento dell’amministrazione comunale uscente, che è davanti a tutti i cittadini, senza possibilità di essere smentita; e nell’ulteriore incapacità di analizzarne pubblicamente le ragioni da parte dei responsabili e delle forze politiche.
La quarta causa sta nella pochezza dell’opposizione di centro-destra, che non ha mai espresso né cultura di governo che non fosse clientelare e improvvisata né vera opposizione ma che ha vivacchiato di piccole co-gestioni e alzate di scudo strumentali. Chi oggi sostiene che l’alternanza naturale tra le parti suggerisce di votare a destra non tiene conto di questa sua evidente nullità.
Questo gigantesco vuoto politico va oggi colmato. Ma ciò implica dire cosa si intende fare e come su lotta alla criminalità, ripresa delle produzioni, gestione differenziata dei rifiuti, valorizzazione delle periferie, dismissione dei baracconi politico-burocratici, sostegno alla partecipazione reale, rilancio dei diritti delle persone e sostegno alle politiche sociali - che sono state attaccate in modo violentissimo, lasciando la città divisa in due ancor più di prima.
Ma la campagna delle primarie ha largamente eluso il cosa fare e come. I programmi non sono stati costruiti in modo partecipativo e sono molto poveri e i candidati si sono confrontati una sola volta. Se paragonata con quella di Milano, è stata davvero poca cosa. Tanto che, in questi mesi, l’avvenimento politico più importante della città è stata la campagna di lotte il “welfare non è un lusso”.
Ma domani si vota. E la domanda - per quelli che intendono comunque votare, perché è un’occasione che in tanti abbiamo voluto – è chi sostenere e perché? La risposta la si deve faticosamente cercare per esclusione. Chi sono, tra i candidati, quelli meno prossimi, per ruolo e storia recenti, alle diverse cause della condizione disastrosa della città e del centro-sinistra? Probabilmente Mancuso e Ranieri. Ma mentre il primo, nel presentarsi, non ha voluto parlare del disastro del centro-sinistra, rivolgendo, lo sguardo esclusivamente all’avversario di destra con il solito adagio del “nemico alle porte”, foriero di tante rimozioni ed errori, il secondo, negli anni, ha almeno avvertito che il disastro era alle porte per cause interne, inascoltato.
Resta un auspicio. Che chiunque vinca, sappia davvero rompere col passato e andare subito al merito delle cose da fare. E sappia farsi aiutare veramente da una squadra ricca di competenze, di nuova cultura politica, di visi, lessico e stili cambiati, di metodo di confronto costante coi cittadini. Una squadra di donne e uomini che sappia innanzitutto ascoltare la città esclusa.
22 dicembre, 2010
Miserevolezza, pericoli, riscatto
 Ieri sulla prima pagina de l’Unità è uscito questo mio articolo, che la redazione ha titolato:
Ieri sulla prima pagina de l’Unità è uscito questo mio articolo, che la redazione ha titolato:Ragazzi, date una lezione a chi vi minaccia.
La pagina e i commenti sono sul sito de l'Unità.
Mercoledì il Parlamento andrà alla votazione finale sulla legge universitaria. A pochi giorni dal 14 dicembre migliaia di persone di nuovo protesteranno. C'è di che preoccuparsi. Per quel giorno e, ben più in generale, per il clima nel Paese. In particolar modo, per quello tra generazioni che, come per tanti insegnanti, è stata la mia ragione di lavoro e di riflessione per molti anni. Non ho voglia di fare appelli né sermoni o rimbrotti. Perché penso che questo sia il tempo di ragionare, con passione civile. Nel farlo non penso affatto che ci si debba rivolgere solo ai giovani. Penso, invece, che ci si debba rivolgere a tutti e, dunque, a se stessi e agli altri. A tutti i cittadini. Che abbiano quindici, diciotto, venticinque o trenta anni o quaranta o sessanta o ottanta. In questa riflessione comune si deve partire - in primo luogo - dal riconoscere una cosa del tutto evidente, che ha cambiato il paesaggio sociale, politico e umano nel quale siamo chiamati a vivere. E che è questa: noi persone «più grandi» stiamo, oggi, consegnando a chi è nato dopo di noi un'Italia peggiore di quella che abbiamo ricevuto in consegna dai nostri genitori. Peggiore per condizioni materiali e per quantità e qualità delle concrete possibilità di lavoro, di reddito, di studio. Peggiore in termini di accesso ai crediti materiali e spirituali in vista dello sviluppo economico e civile e dell'imprenditorialità umana. Peggiore per quanto riguarda il riconoscimento del merito e la possibilità di fare parte della ricerca delle soluzioni ai problemi della vita comune. Peggiore per presidio delle procedure e delle regole della civile convivenza e per la tenuta di ritualità e occasioni comunitarie. Peggiore in termini di protezione di fronte all'ineguaglianza e alle avversità della vita. Peggiore riguardo al fare fronte alle normali fragilità, difficoltà personali e alla possibilità di commettere errori. Peggiore per estensione - reale e percepita - degli orizzonti di speranza. È nel bel mezzo di questo paesaggio - impoverito, depresso, che crea ansia e rancori quotidiani, paure e rabbia diffuse e persistenti - che questa destra si è rivolta ai giovani chiedendo loro di approvare le nuove norme che li riguardavano e omettendo, tuttavia, di fornire occasioni per confrontarsi nel merito. «Noi facciamo le leggi secondo quanto crediamo perché abbiamo vinto le elezioni. Ma voi leggetele bene e convincetevene. Se non lo fate, vi state facendo strumentalizzare». Così, non è stata neanche considerata la civile possibilità che i destinatari di misure di governo possano essere in disaccordo ma non per questo preda di strumentalizzazioni, che possano essere portatori di osservazioni e proposte importanti o utili, che possano notare incongruenze tra intenzioni e mezzi. Dietro questo vi è un'idea povera - e involutiva in termini democratici - della politica: la politica si esprime e decide secondo i rapporti di forza. Punto. Altre volte la destra ha aggiunto a questo una miserevolezza umana: «Studiate e non manifestate. Pensate all'amore e non ai cortei». Come se fossero cose in contraddizione. Mentre non lo sono mai state. Tale miserevolezza rivela un'assenza di esperienza e curiosità umane che impediscono di pensare che si può, al contempo, studiare e partecipare alle cose pubbliche e che è tanto grande la gioia di stare insieme, parlarsi, cercare comunità, incontrarsi e domandarsi del proprio tempo che viene esaltata la possibilità di amicizia e anche di incontro amoroso. Ma - va pur detto - anche nell'opposizione troppo spesso, al di là di intenzioni o meno, è prevalso il riflesso teso a ricondurre la protesta alla vicenda politica contingente, alle sue esigenze particolari, al suo gergo. Da tutto questo deriva un pensiero, diffuso nelle nuove generazioni, che è legittimo: non siamo rappresentati. E' in questa atmosfera che si manifesterà di nuovo. L'ombra del 14 dicembre peserà. Perché ha svelato tutta la gravità della scena italiana riguardo il rapporto tra generazioni. Tanto che tantissimi hanno sentito di condividere l'esplosione di rabbia anche senza partecipare alle sue azioni. Non si è trattato di provocatori isolati. Non si può rimuovere la forza di una rabbia radicata e diffusa. Però non si può neanche nascondere che le cose sono complicate dal fatto che molti indizi fanno sospettare che qualcuno ha voluto tessere trappole brutte e pericolose. E che a farlo non siano stati né la stragrande maggioranza dei manifestanti né i poliziotti. Tali segni, in questi giorni, vengono purtroppo confermati dall'insistenza su un possibile esito terribile per la giornata di mercoledì prossimo. Si tratta di una profezia urlata. In particolar modo da una componente specifica della destra di governo, che ha una storia politica mai rivisitata, fatta anche di brutte vicende di piazza nella propria giovinezza, rimosse e mai ri-elaborate. Di fronte a questa insistenza su un esito nefasto della prossima protesta acquista ancor maggiore importanza una riflessione su come si manifesterà mercoledì. E diventa ancor più urgente il grande bisogno di smentire una storia italiana che ha spesso depotenziato grandi movimenti, riducendone una parte ai rituali prevedibili dello scontro di piazza e una ben più grande alla mancanza di parola. Questa smentita è forse finalmente a portata di mano. Perché questo movimento sta insegnando a noi - altro che sermoni nostri ai giovani! - una nuova modalità di azione civile. I titoli dei libri davanti ai cortei, il salire sulle gru e sui tetti, il mostrarsi insieme ai monumenti sono stato questo. E, a me come a tanti, è venuto alla mente Gandhi. È lì che vanno trovati i modelli di azione potente che servono a fare valere le ragioni di chi è escluso dal futuro. E penso quanto sarebbe potente se mercoledì - anziché porsi il problema di forzare la zona rossa del centro di Roma, messa lì ed estesa ad arte per attirare nelle vecchie trappole - si decidesse di sdraiarsi per terra, nella Capitale e in cento altre città. Vestiti di bianco per bloccare tutto, in silenzio. Come suggerito dalle nevicate di questi giorni. Pacifiche e implacabili.
17 dicembre, 2010
Quattordici dicembre e paesaggio politico
Sarò lungo.
La rabbia di una generazione inascoltata – e non i black block – ha mostrato, il 14 dicembre, come nel resto d’Europa, la potenza di una cesura brutale tra generazioni. Mi fa quasi impressione citarmi da solo ma davvero l’avevo appena detto in tv: noi abbiamo lasciato ai nostri figli un paese molto peggiore di quello che avevamo ereditato. E i ragazzi lo sanno. Ogni giorno sulla loro pelle sparisce l’orizzonte di speranza.
Quest’è.
Al contempo c’è la politica. Al netto delle sue cose vecchie e deprimenti – che il principe de Curtis le sapeva cinquant'anni prima della Gabanelli – mister Berlusconi è stato confermato. Manovre e fibrillazioni continueranno. Continuerà l’altalena tra elezioni, ancora assai probabili, e tirare avanti. Il clima resterà incerto.
Se si andasse a elezioni tuttavia non ci si può dimenticare che vi sono e resteranno sulla scena talune costanti che colorano il nostro paesaggio politico. A destra. E a sinistra. La destra manterrà le tre fondamentali caratteristiche di questi anni. Che sono. Una: obbedire a un capo che non sta bene di testa e ha sempre confuso e fatto confondere questioni generali e anche legittimamente di parte con forti interessi privati e personali. Due: essere capace di tutto e dunque ledere, minacciare, spezzare le procedure e le regole, che sono il sale di ogni assetto civile e di ogni modello politico liberale. Tre: essere, in aggiunta, capace di poco o nulla – che non siano i fatti suoi - in termini realizzativi. In sede storica ci si dovrà pur chiedere com’è che l’Italia, più di altri luoghi, è “laboratorio” di queste cose. Dunque, si tratta di una sorta di summa di varie cose, che sono parti del nostro passato e che oggi stanno dinanzi a noi in modo congiunto e potentissimo. C’è la politica “capace di tutto ma buona a nulla” di montanelliana memoria. C’è la versione odierna della “borghesia sovversiva” di cui parlava già Salvemini. C’è il “cesarismo” specificamente italico di cui parlava Gramsci. Il quale, peraltro, va ben oltre i recinti della destra – con il moltiplicarsi, ovunque, dei partiti personali, dove le dinamiche sono tutte impoverite. Perché sono legate al capo, più e molto più lungamente che nelle altre democrazie occidentali. Legate e perciò ridotte intorno all’essere ognuno in situazione di sudditanza / dipendenza / distanza / vicinanza / interpretazione / fedeltà / tradimento nei riguardi di un solo attore preminente. Con gli aderenti a quella parte che, così, assumono la veste di tifosi e non di partecipanti, di sudditi e non di cittadini. Per troppi aspetti non si sottraggono a ciò Fini, Grillo, Vendola. E ancor più Di Pietro – il cui partito personale, inoltre, ha avuto e mantiene nel tempo la tendenza precipua ad allevare “mariuoli in corpo”… come si è visto. Non fanno parte di questo novero – sia pure con altri difetti – il Pd, la sinistra e, in qualche modo e nonostante Bossi, la Lega.
Tutto questo – la politica per come è e per come si discute in Italia - evidentemente, conosce una variegata e perpetua vicenda quotidiana. Che ci angustia e deprime.
Ma che ha anche una “esistenza separata” dalle vicende concrete della vita sociale e anche individuale di noi cittadini. Vita nella quale il focus è sull’arrivare alla fine del mese, trovare una scuola ok per i figli, ridurre i danni di metropoli e territori divelti e malsani, mantenere il lavoro, pagare il mutuo, capire cosa faranno i figli da grandi quando lo sono già grandi, evitare i cappi di banche o di criminali sulle imprese, ecc. In un’idea minimamente accettabile di politica, i problemi veri sono la cosa di cui parlare e da cui partire per dire, proporre, agire. E sarebbe compito dell’opposizione – di centro, di sinistra, di centro-sinistra – capire, innanzitutto, com’è che queste cose della vita vera – alle quali il governo e il Berlusca non rispondono - non si traducano, però, in “più forza all’opposizione”. Perché il declino del paese, che coinvolge le nostre esistenze e l’orizzonte di speranza non intacca chi ne è il primo responsabile?
Ecco: nel paesaggio politico queste domande non sono centrali. Vengono qui e lì balbettate. O fanno parte del commento dei commentatori. Non si sostanziano in azione politica, in proposta, in innovazione di modi, di idee, di metodi, di persone. Dunque vi è un’involontaria ma forte collusione tra berlusconismo e pochezza dell’opposizione. Beninteso: certe volte appaiono barlumi di cose più sensate. Qualcuno avanza proposte su come affrontare la questione dell’evasione fiscale o della crisi produttiva o della povertà o della scuola. Si entra nel merito. Si argomenta. Ma sono voci inascoltate in mezzo al solito frastuono di fondo, uguale, immancabilmente, a se stesso. La rappresentanza – in senso minimamente credibile – non c’è per noi. Che abbiamo lavoro e reddito. Figurati per i nostri ragazzi.
E la politica è porta a porta e ballarò, trallallero e trallalà. Sì, il solito frastuono: dove prevale lo slogan, la dietrologia, l’ultimo boatos inverificabile, la manovra tattica, lo spot, l’urlo e la sua replica. Così l’antiberlusconismo – anche grazie alla personalizzazione parossistica della nostra politica – è speculare al berlusconismo. Certo, con meno disponibilità di denaro e meno polvere da sparare; ma con poca distanza effettiva dal modello avversato. Il frastuono è lo stesso e purtroppo la critica al berlusconismo, con quei temi e quei toni, spesso si è fatto ed è confuso in esso, una sorta di controcanto stonato. Che noi e ancor più i ragazzi percepiscono come tale.
Per tutti quel che manca è la parola propositiva e le proposte sul da farsi trovate in via partecipativa. E’ questa la questione delle questioni. La parola che cerca cosa fare e quella che accompagna i processi democratici è la parola che è emarginata dalla scena, rara e coperta. Davanti a questa mancanza, come meravigliarsi che esplode la rabbiosa impotenza…

La violenza è, tuttavia, un problema. E’ solo rabbia? C’è da chiederselo. Ci sono tradizioni ideologiche vetuste ed ereditate che riaffiorano? Forse e anche. C’è qualche black block? Forse e anche. Ma la questione centrale è che c’è una generazione (o forse due generazioni e mezzo) che da quasi 4 lustri sta/stanno sulla soglia, in un paese senza avvenire. E che non dà, appunto, parole propositive, non nomina le strade da prendere, non indica possibilità. Non c’è lavoro fisso. Non c’è giusto salario. Non c’è denaro per la scuola del ventunesimo secolo. Non ce ne è per la ricerca. Non avranno pensione. Non possono chiedere un mutuo. Non avranno un prestito per aprire un’attività.
Contro tutto ciò c’è solo impeto rabbioso? No. Altre volte non c’è l’impeto rabbioso. C’è l’immaginario creativo. Migliore. I tetti, le gru, i libri attaccati ad aprire cortei pacifici. Happening di speranza. Sono possibili premesse al passo successivo. Condizione necessaria. Ma non sufficiente. Ci vorrebbe una sorta di gandhismo occidentale – un sapere chiedere e creare in proprio. Zone liberate, fatte di lavoro comunitario e di produzioni sostenibili. Attività che prendono dimensione globale e locale insieme. Rottura dei conservatorismi del credito. Scuole pubbliche non necessariamente statali. Un respiro libertario. Che rompa il duopolio tra statalismo e oppressione della rendita legata ai soliti noti. Difficile, certo. Ma da esplorare, riscoprire, indagare, provare… Qualche segno di questa via, timido, c’è.
Oggi però, ancora prevale, anche nei movimenti,il più semplice; che è il ricadere sotto vecchie modalità. Chiedere soluzioni stataliste. Opporsi senza proporre. Abbracciare, nel dibattere, un rivendicazionismo solito, legato alle retoriche di chi sa porgere le cose con maggior enfasi. O ci sono le sirene e gli ombrelli di chi già è organizzato. Con propri mezzi, gerghi, modi. E vuole tirare tutto dalla propria. Come spesso è già avvenuto. E c’è Grillo che urla e urla contro. E quando propone lo fa senza confrontarsi. O ci sono i proclami di Vendola – dove la parola si fa vezzosa, cripto profetica, simil onirica – per contrapporsi a tutto ciò con il semplice tentativo di lirismo. Che tuttavia, fatica a tentare di dare risposte: cosa si deve fare per.
C’è anche un’altra dimensione – importante – del paesaggio. C’è una scena depressa e bastonata. E si deve poter aspirare a gioie, vie di uscita. Non deliranti ma promettenti sì. E evocare speranza è di grande importanza. Ma accennare a speranza senza co-costruire prospettive realistiche e risposte possibili mi pare un esercizio monco. E’ comprensibile se si tratta di movimenti. In una prima fase. Ma diventa una cosa esiziale quando si tratta di proposta fatta da forze politiche.
Questa situazione fa dire a più d’un commentatore “avvertito” che c’è una riformulazione del rapporto tra politica e vita sociale molto profonda e che richiede impegno di lunga da lena. Impegno da spendere contro la degenerazione della società avuta grazie al berlusconismo o grazie – dicono i più sofisticati – a una osmosi tra berlusconismo e elementi di mutamento profondo già in corso e che si sono potenziati ed estesi a dismisura. E che hanno davvero mutato il paesaggio in termini non solo politici ma antropologici. Ciò è ovviamente vero e molto condivisibile, un buon punto da cui riprendere a ragionare. Ma è importante sapere chi lo afferma. Perché chi lo dice deve essere credibile. Non può esserci il sospetto che lo dice per cooptare, per l’ennesima volta, lo scontento, strumentalizzarlo, portarlo a sé senza mai mutare alcunché di sé. Dunque, non è credibile chi fa queste analisi a partire da una richiesta di adesione a una parte già organizzata, chiusa, strutturata, fatta di linguaggi, gerarchie, ceto stabilizzato, proposta formulata. Com’è la gran parte del Pd, di SeL, dei comunisti, di IdV. Con alcune eccezioni. Che vivono una condizione scomoda.
E’ più credibile, invece, chi analizza i nessi tra berlusconismo e degenerazioni del tessuto sociale profondo avendo abitato un territorio a cavallo tra società e aspirazione a una nuova rappresentanza e a un nuovo metodo della politica. Questo qualcuno è tanti e tante di noi. Che, senza avere aderito alla finta società civile - quella telecomandata dagli apparati - ha cercato nuove vie di rappresentanza e partecipazione effettiva. E che, volta dopo volta, ha vissuto e vive la condizione di impotenza e, al contempo di continua, disperata supplenza dei compiti che spetterebbero alla politica nella sua relazione di ascolto autentico, mediazione e proposta.
Questa parola, forse, può risuonare nel frastuono. E’ ancora possibile. Ma deve avere alcune caratteristiche. Che ne sostengano il tono, l’intensità. La prima è che chi la pronuncia deve essere credibile. Per storia e per capacità. La seconda è che ci vuole non un singolo ma un coro di voci, un ensemble ricco e credibile. La terza è che sia capace di proposte vere: né utopie fumose né un eccesso disperato di tanti piccoli realismi… Lontano dalle ideologie del secolo passato e dal mero compito immediato.
Difficile, difficile. Eppure qualcosa muove e si muove. E c’è da pensare a una prospettiva.
La rabbia di una generazione inascoltata – e non i black block – ha mostrato, il 14 dicembre, come nel resto d’Europa, la potenza di una cesura brutale tra generazioni. Mi fa quasi impressione citarmi da solo ma davvero l’avevo appena detto in tv: noi abbiamo lasciato ai nostri figli un paese molto peggiore di quello che avevamo ereditato. E i ragazzi lo sanno. Ogni giorno sulla loro pelle sparisce l’orizzonte di speranza.
Quest’è.
Al contempo c’è la politica. Al netto delle sue cose vecchie e deprimenti – che il principe de Curtis le sapeva cinquant'anni prima della Gabanelli – mister Berlusconi è stato confermato. Manovre e fibrillazioni continueranno. Continuerà l’altalena tra elezioni, ancora assai probabili, e tirare avanti. Il clima resterà incerto.
Se si andasse a elezioni tuttavia non ci si può dimenticare che vi sono e resteranno sulla scena talune costanti che colorano il nostro paesaggio politico. A destra. E a sinistra. La destra manterrà le tre fondamentali caratteristiche di questi anni. Che sono. Una: obbedire a un capo che non sta bene di testa e ha sempre confuso e fatto confondere questioni generali e anche legittimamente di parte con forti interessi privati e personali. Due: essere capace di tutto e dunque ledere, minacciare, spezzare le procedure e le regole, che sono il sale di ogni assetto civile e di ogni modello politico liberale. Tre: essere, in aggiunta, capace di poco o nulla – che non siano i fatti suoi - in termini realizzativi. In sede storica ci si dovrà pur chiedere com’è che l’Italia, più di altri luoghi, è “laboratorio” di queste cose. Dunque, si tratta di una sorta di summa di varie cose, che sono parti del nostro passato e che oggi stanno dinanzi a noi in modo congiunto e potentissimo. C’è la politica “capace di tutto ma buona a nulla” di montanelliana memoria. C’è la versione odierna della “borghesia sovversiva” di cui parlava già Salvemini. C’è il “cesarismo” specificamente italico di cui parlava Gramsci. Il quale, peraltro, va ben oltre i recinti della destra – con il moltiplicarsi, ovunque, dei partiti personali, dove le dinamiche sono tutte impoverite. Perché sono legate al capo, più e molto più lungamente che nelle altre democrazie occidentali. Legate e perciò ridotte intorno all’essere ognuno in situazione di sudditanza / dipendenza / distanza / vicinanza / interpretazione / fedeltà / tradimento nei riguardi di un solo attore preminente. Con gli aderenti a quella parte che, così, assumono la veste di tifosi e non di partecipanti, di sudditi e non di cittadini. Per troppi aspetti non si sottraggono a ciò Fini, Grillo, Vendola. E ancor più Di Pietro – il cui partito personale, inoltre, ha avuto e mantiene nel tempo la tendenza precipua ad allevare “mariuoli in corpo”… come si è visto. Non fanno parte di questo novero – sia pure con altri difetti – il Pd, la sinistra e, in qualche modo e nonostante Bossi, la Lega.
Tutto questo – la politica per come è e per come si discute in Italia - evidentemente, conosce una variegata e perpetua vicenda quotidiana. Che ci angustia e deprime.
Ma che ha anche una “esistenza separata” dalle vicende concrete della vita sociale e anche individuale di noi cittadini. Vita nella quale il focus è sull’arrivare alla fine del mese, trovare una scuola ok per i figli, ridurre i danni di metropoli e territori divelti e malsani, mantenere il lavoro, pagare il mutuo, capire cosa faranno i figli da grandi quando lo sono già grandi, evitare i cappi di banche o di criminali sulle imprese, ecc. In un’idea minimamente accettabile di politica, i problemi veri sono la cosa di cui parlare e da cui partire per dire, proporre, agire. E sarebbe compito dell’opposizione – di centro, di sinistra, di centro-sinistra – capire, innanzitutto, com’è che queste cose della vita vera – alle quali il governo e il Berlusca non rispondono - non si traducano, però, in “più forza all’opposizione”. Perché il declino del paese, che coinvolge le nostre esistenze e l’orizzonte di speranza non intacca chi ne è il primo responsabile?
Ecco: nel paesaggio politico queste domande non sono centrali. Vengono qui e lì balbettate. O fanno parte del commento dei commentatori. Non si sostanziano in azione politica, in proposta, in innovazione di modi, di idee, di metodi, di persone. Dunque vi è un’involontaria ma forte collusione tra berlusconismo e pochezza dell’opposizione. Beninteso: certe volte appaiono barlumi di cose più sensate. Qualcuno avanza proposte su come affrontare la questione dell’evasione fiscale o della crisi produttiva o della povertà o della scuola. Si entra nel merito. Si argomenta. Ma sono voci inascoltate in mezzo al solito frastuono di fondo, uguale, immancabilmente, a se stesso. La rappresentanza – in senso minimamente credibile – non c’è per noi. Che abbiamo lavoro e reddito. Figurati per i nostri ragazzi.
E la politica è porta a porta e ballarò, trallallero e trallalà. Sì, il solito frastuono: dove prevale lo slogan, la dietrologia, l’ultimo boatos inverificabile, la manovra tattica, lo spot, l’urlo e la sua replica. Così l’antiberlusconismo – anche grazie alla personalizzazione parossistica della nostra politica – è speculare al berlusconismo. Certo, con meno disponibilità di denaro e meno polvere da sparare; ma con poca distanza effettiva dal modello avversato. Il frastuono è lo stesso e purtroppo la critica al berlusconismo, con quei temi e quei toni, spesso si è fatto ed è confuso in esso, una sorta di controcanto stonato. Che noi e ancor più i ragazzi percepiscono come tale.
Per tutti quel che manca è la parola propositiva e le proposte sul da farsi trovate in via partecipativa. E’ questa la questione delle questioni. La parola che cerca cosa fare e quella che accompagna i processi democratici è la parola che è emarginata dalla scena, rara e coperta. Davanti a questa mancanza, come meravigliarsi che esplode la rabbiosa impotenza…

La violenza è, tuttavia, un problema. E’ solo rabbia? C’è da chiederselo. Ci sono tradizioni ideologiche vetuste ed ereditate che riaffiorano? Forse e anche. C’è qualche black block? Forse e anche. Ma la questione centrale è che c’è una generazione (o forse due generazioni e mezzo) che da quasi 4 lustri sta/stanno sulla soglia, in un paese senza avvenire. E che non dà, appunto, parole propositive, non nomina le strade da prendere, non indica possibilità. Non c’è lavoro fisso. Non c’è giusto salario. Non c’è denaro per la scuola del ventunesimo secolo. Non ce ne è per la ricerca. Non avranno pensione. Non possono chiedere un mutuo. Non avranno un prestito per aprire un’attività.
Contro tutto ciò c’è solo impeto rabbioso? No. Altre volte non c’è l’impeto rabbioso. C’è l’immaginario creativo. Migliore. I tetti, le gru, i libri attaccati ad aprire cortei pacifici. Happening di speranza. Sono possibili premesse al passo successivo. Condizione necessaria. Ma non sufficiente. Ci vorrebbe una sorta di gandhismo occidentale – un sapere chiedere e creare in proprio. Zone liberate, fatte di lavoro comunitario e di produzioni sostenibili. Attività che prendono dimensione globale e locale insieme. Rottura dei conservatorismi del credito. Scuole pubbliche non necessariamente statali. Un respiro libertario. Che rompa il duopolio tra statalismo e oppressione della rendita legata ai soliti noti. Difficile, certo. Ma da esplorare, riscoprire, indagare, provare… Qualche segno di questa via, timido, c’è.
Oggi però, ancora prevale, anche nei movimenti,il più semplice; che è il ricadere sotto vecchie modalità. Chiedere soluzioni stataliste. Opporsi senza proporre. Abbracciare, nel dibattere, un rivendicazionismo solito, legato alle retoriche di chi sa porgere le cose con maggior enfasi. O ci sono le sirene e gli ombrelli di chi già è organizzato. Con propri mezzi, gerghi, modi. E vuole tirare tutto dalla propria. Come spesso è già avvenuto. E c’è Grillo che urla e urla contro. E quando propone lo fa senza confrontarsi. O ci sono i proclami di Vendola – dove la parola si fa vezzosa, cripto profetica, simil onirica – per contrapporsi a tutto ciò con il semplice tentativo di lirismo. Che tuttavia, fatica a tentare di dare risposte: cosa si deve fare per.
C’è anche un’altra dimensione – importante – del paesaggio. C’è una scena depressa e bastonata. E si deve poter aspirare a gioie, vie di uscita. Non deliranti ma promettenti sì. E evocare speranza è di grande importanza. Ma accennare a speranza senza co-costruire prospettive realistiche e risposte possibili mi pare un esercizio monco. E’ comprensibile se si tratta di movimenti. In una prima fase. Ma diventa una cosa esiziale quando si tratta di proposta fatta da forze politiche.
Questa situazione fa dire a più d’un commentatore “avvertito” che c’è una riformulazione del rapporto tra politica e vita sociale molto profonda e che richiede impegno di lunga da lena. Impegno da spendere contro la degenerazione della società avuta grazie al berlusconismo o grazie – dicono i più sofisticati – a una osmosi tra berlusconismo e elementi di mutamento profondo già in corso e che si sono potenziati ed estesi a dismisura. E che hanno davvero mutato il paesaggio in termini non solo politici ma antropologici. Ciò è ovviamente vero e molto condivisibile, un buon punto da cui riprendere a ragionare. Ma è importante sapere chi lo afferma. Perché chi lo dice deve essere credibile. Non può esserci il sospetto che lo dice per cooptare, per l’ennesima volta, lo scontento, strumentalizzarlo, portarlo a sé senza mai mutare alcunché di sé. Dunque, non è credibile chi fa queste analisi a partire da una richiesta di adesione a una parte già organizzata, chiusa, strutturata, fatta di linguaggi, gerarchie, ceto stabilizzato, proposta formulata. Com’è la gran parte del Pd, di SeL, dei comunisti, di IdV. Con alcune eccezioni. Che vivono una condizione scomoda.
E’ più credibile, invece, chi analizza i nessi tra berlusconismo e degenerazioni del tessuto sociale profondo avendo abitato un territorio a cavallo tra società e aspirazione a una nuova rappresentanza e a un nuovo metodo della politica. Questo qualcuno è tanti e tante di noi. Che, senza avere aderito alla finta società civile - quella telecomandata dagli apparati - ha cercato nuove vie di rappresentanza e partecipazione effettiva. E che, volta dopo volta, ha vissuto e vive la condizione di impotenza e, al contempo di continua, disperata supplenza dei compiti che spetterebbero alla politica nella sua relazione di ascolto autentico, mediazione e proposta.
Questa parola, forse, può risuonare nel frastuono. E’ ancora possibile. Ma deve avere alcune caratteristiche. Che ne sostengano il tono, l’intensità. La prima è che chi la pronuncia deve essere credibile. Per storia e per capacità. La seconda è che ci vuole non un singolo ma un coro di voci, un ensemble ricco e credibile. La terza è che sia capace di proposte vere: né utopie fumose né un eccesso disperato di tanti piccoli realismi… Lontano dalle ideologie del secolo passato e dal mero compito immediato.
Difficile, difficile. Eppure qualcosa muove e si muove. E c’è da pensare a una prospettiva.
13 dicembre, 2010
La medicina per curare il pessimismo
queste note sono state pubblicate da Repubblica Napoli l'11 dicembre.
Scendo dal treno con i sensi di colpa. Lavoro al Nord, nella città considerata la più vivibile d’Italia. Scambio qualche battuta con i miei compagni di viaggio. Ormai sono tanti e tanti i napoletani che vivono fuori. In crescita costante: 6 per mille ogni anno da un decennio. Ricchi e poveri. E quando ci sveglieremo con i dati del censimento del 2011 scopriremo che la nostra bella città sarà scesa ben sotto il milione di abitanti, per la prima volta dal 1951. Siamo i napoletani che rientrano per il fine settimana. Molte migliaia. Se facessimo una lista elettorale forse conteremmo pure qualcosa. Ma ognuno fa quel che può. In posti diversi e lontani. La prospettiva politica, beninteso in senso proprio - “pensare al governo della nostra città” – c’è. Ma la fiducia nella politica - così com’è - è esilissima. Più e più volte sento ripetere: non voterò. E’ così anche altrove. Ma qui di più. “Il mio è un esilio volontario” – dice una signora. Ma l’appartenenza a Napoli resta formidabilmente forte. Cocciuta. E superbamente orgogliosa. Guai chi ne parla male nei luoghi lontani. Guai a non difendere i colori della squadra. Guai a dismettere la parlata, il tono, l’ironia fatta come facciamo noi.

Ad aspettare il treno ci sono mogli, mariti, fidanzati, fratelli, papà, mamme, amici. Oppure nessuno. A ottobre, con i dati di legambiente sotto braccio, un ragazzo con un sorriso dolce, mentre il treno si avvicinava alla città mi diceva “Guarda che meraviglia di cielo, che città bella abbiamo; eppure anche qui da noi l’aria è irrespirabile”. L’altro giorno stessa scena. Questa volta a citare la classifica delle città meno vivibili è un ragazzo che ha un contratto precarissimo in una piccola città del Nord, un diploma da ragioniere, nessuna prospettiva di carriera. “E’ triste essere via” – dice – “ma i miei amici qui sono più tristi di me. Per com’è la città”. Un coetaneo aggiunge: “E’ della serie: nonsolomonnezza”. “Vorremmo tornare tutti – dice una bella ragazza – ma..” Si ferma. Come sulla soglia di una pena. Guardo di lato. Mi fa male proprio la sospensione della frase. Poi qualcuno lo deve interrompere il silenzio. “Come tornare? E a fare cosa? E con questi qui, che pure cercheranno i voti…” Lo dice a noi e a se stesso un signore di mezza età. Si fa di nuovo silenzio.
Napoli è affranta in modo straziante. Lo sente e lo vede ogni ora chi ci vive. E chi vive fuori lo sente come pena interiore, acuta e cronica insieme. Difendere la nostra condizione quotidiana – in faccia a chi ci chiede come è potuto succedere – è ogni volta un compito davvero arduo.
Si avvicinano le elezioni. Il non voto cresce da tempo. E siamo diventati pessimisti in tanti. Non perché lo siamo noi. Ma perché c’è motivo di esserlo. Eppure c’è da riprendere la battaglia per curarsi. Per curare la città. Non si può demordere. Vanno fatte le proposte. Manutenzione ordinaria. Monnezza. Lavoro e formazione. Criminalità. Smog. Scuole... Molte migliaia di napoletani le saprebbero fare le proposte, lavorando insieme: hanno i dati, hanno le competenze. E’ questo il retroterra per curarsi. Ma per liberare questo retroterra, c’è prima da fare un’altra cosa. Prima di riprendere le proposte e renderle credibili e realistiche – quanto tempo ci vuole, quanto costa, chi lo fa? - ci vuole un momento di verità. Impietoso. E’ un compito ingrato. Ma per poter parlare di cosa va fatto e come, si devono poter fare le domande vere su cosa è successo. Com’è potuto succedere che non c’è la raccolta differenziata? Date, nomi, decisioni prese oppure no. Quanti soldi ci sono nelle casse del comune? Scelte. Colpe esterne e interne. E crude cifre. Quando finiranno i cantieri aperti e come? Date e motivi. Perché non c’è manutenzione delle cose? Procedure, bilanci, scelte.
Non si tratta di trovare il colpevole. Sul quale fare ricadere tutto. Per poi ricominciare come prima. Si tratta di analizzare. Per proporre, subito dopo, le cose possibili da fare. Ma da fare in un altro modo. E magari con altre persone.
Chi è disposto e saprà fare un bilancio politico, insieme alla città? In una città europea normale lo farebbe il sindaco e la giunta uscenti. Dubito che avverrà. Sarebbe bene, allora, che lo facessero i candidati a sindaco. Non per piangersi addosso. Né per ripetere le solite accuse strumentali. Ma per poter ripartire senza fare finta che il danno non ci sia stato.
Ora ci vuole verità. In senso antico e letterale: aletheia, “non nascondimento”. “Cosa è successo? Perché siamo messi così?” – se lo chiedeva una ragazza che lavora lontano, mentre tirava giù la valigia. Ecco. Se si risponde, allora possiamo trovare le cure per Napoli e le molte migliaia di medici curanti che sono necessari. Altrimenti no.
Scendo dal treno con i sensi di colpa. Lavoro al Nord, nella città considerata la più vivibile d’Italia. Scambio qualche battuta con i miei compagni di viaggio. Ormai sono tanti e tanti i napoletani che vivono fuori. In crescita costante: 6 per mille ogni anno da un decennio. Ricchi e poveri. E quando ci sveglieremo con i dati del censimento del 2011 scopriremo che la nostra bella città sarà scesa ben sotto il milione di abitanti, per la prima volta dal 1951. Siamo i napoletani che rientrano per il fine settimana. Molte migliaia. Se facessimo una lista elettorale forse conteremmo pure qualcosa. Ma ognuno fa quel che può. In posti diversi e lontani. La prospettiva politica, beninteso in senso proprio - “pensare al governo della nostra città” – c’è. Ma la fiducia nella politica - così com’è - è esilissima. Più e più volte sento ripetere: non voterò. E’ così anche altrove. Ma qui di più. “Il mio è un esilio volontario” – dice una signora. Ma l’appartenenza a Napoli resta formidabilmente forte. Cocciuta. E superbamente orgogliosa. Guai chi ne parla male nei luoghi lontani. Guai a non difendere i colori della squadra. Guai a dismettere la parlata, il tono, l’ironia fatta come facciamo noi.

Ad aspettare il treno ci sono mogli, mariti, fidanzati, fratelli, papà, mamme, amici. Oppure nessuno. A ottobre, con i dati di legambiente sotto braccio, un ragazzo con un sorriso dolce, mentre il treno si avvicinava alla città mi diceva “Guarda che meraviglia di cielo, che città bella abbiamo; eppure anche qui da noi l’aria è irrespirabile”. L’altro giorno stessa scena. Questa volta a citare la classifica delle città meno vivibili è un ragazzo che ha un contratto precarissimo in una piccola città del Nord, un diploma da ragioniere, nessuna prospettiva di carriera. “E’ triste essere via” – dice – “ma i miei amici qui sono più tristi di me. Per com’è la città”. Un coetaneo aggiunge: “E’ della serie: nonsolomonnezza”. “Vorremmo tornare tutti – dice una bella ragazza – ma..” Si ferma. Come sulla soglia di una pena. Guardo di lato. Mi fa male proprio la sospensione della frase. Poi qualcuno lo deve interrompere il silenzio. “Come tornare? E a fare cosa? E con questi qui, che pure cercheranno i voti…” Lo dice a noi e a se stesso un signore di mezza età. Si fa di nuovo silenzio.
Napoli è affranta in modo straziante. Lo sente e lo vede ogni ora chi ci vive. E chi vive fuori lo sente come pena interiore, acuta e cronica insieme. Difendere la nostra condizione quotidiana – in faccia a chi ci chiede come è potuto succedere – è ogni volta un compito davvero arduo.
Si avvicinano le elezioni. Il non voto cresce da tempo. E siamo diventati pessimisti in tanti. Non perché lo siamo noi. Ma perché c’è motivo di esserlo. Eppure c’è da riprendere la battaglia per curarsi. Per curare la città. Non si può demordere. Vanno fatte le proposte. Manutenzione ordinaria. Monnezza. Lavoro e formazione. Criminalità. Smog. Scuole... Molte migliaia di napoletani le saprebbero fare le proposte, lavorando insieme: hanno i dati, hanno le competenze. E’ questo il retroterra per curarsi. Ma per liberare questo retroterra, c’è prima da fare un’altra cosa. Prima di riprendere le proposte e renderle credibili e realistiche – quanto tempo ci vuole, quanto costa, chi lo fa? - ci vuole un momento di verità. Impietoso. E’ un compito ingrato. Ma per poter parlare di cosa va fatto e come, si devono poter fare le domande vere su cosa è successo. Com’è potuto succedere che non c’è la raccolta differenziata? Date, nomi, decisioni prese oppure no. Quanti soldi ci sono nelle casse del comune? Scelte. Colpe esterne e interne. E crude cifre. Quando finiranno i cantieri aperti e come? Date e motivi. Perché non c’è manutenzione delle cose? Procedure, bilanci, scelte.
Non si tratta di trovare il colpevole. Sul quale fare ricadere tutto. Per poi ricominciare come prima. Si tratta di analizzare. Per proporre, subito dopo, le cose possibili da fare. Ma da fare in un altro modo. E magari con altre persone.
Chi è disposto e saprà fare un bilancio politico, insieme alla città? In una città europea normale lo farebbe il sindaco e la giunta uscenti. Dubito che avverrà. Sarebbe bene, allora, che lo facessero i candidati a sindaco. Non per piangersi addosso. Né per ripetere le solite accuse strumentali. Ma per poter ripartire senza fare finta che il danno non ci sia stato.
Ora ci vuole verità. In senso antico e letterale: aletheia, “non nascondimento”. “Cosa è successo? Perché siamo messi così?” – se lo chiedeva una ragazza che lavora lontano, mentre tirava giù la valigia. Ecco. Se si risponde, allora possiamo trovare le cure per Napoli e le molte migliaia di medici curanti che sono necessari. Altrimenti no.
06 dicembre, 2010
Appelli vari, rimozioni e un annuncio (piccolo)
Girano e riceviamo appelli. Tanti e vari.
C’è l’appello che invita alla veglia per il risveglio di Napoli:
mercoledì 15 dicembre, piazza del Plebiscito dalle 19 alle 20,30. Con una candela e tanto silenzio.
Che chiama ad andarci e basta. E aggiunge che è
“….perché non c’è altro da dire , ma c’è il nostro assordante silenzio che non è indifferenza! Il fatalismo di chi pensa che nulla può cambiare, nasconde spesso un vuoto di passioni e di idee che non rispecchia affatto l’indole di molti napoletani che continuano a credere di poter fare ancora qualcosa!”
Non male. Anche la simbologia, infatti, necessita ormai di un cambio..
E c’è l’appello dalle firme importanti – gli intellettuali che vogliono che Napoli abbia una speranza:
Gae Aulenti, Francesco Barbagallo, Roberto Esposito, Giuseppe Galasso, Ernesto Galli Della Loggia, Raffaele La Capria, Mario Martone, Elisabetta Rasy, Aldo Schiavone, Toni Servillo.
Leggete. Fate sapere che ne pensate.
Poi, più “politicamente”, gira l’appello a favore della candidatura di Libero Mancuso a sindaco. Che è una brava persona. Peccato – lo dico con vera tristezza - che l’appello ha un gravissimo difetto. Di rimozione. Infatti non nomina - neanche di striscio! – il fatto che la città è stata governata per ben 4 mandati dal centro-sinistra e che se sta così la nostra parte politica c’entrerà pure qualcosa! Sì, la rimozione... quella cosa lì, per la quale fa troppo dolore e fatica passare per la crudezza delle cose per uscire dalla m….
O no?
Infine un piccolo annuncio:
mercoledì sera, 8 dicembre, alle ore 23,15 sono in Tv su Rai 3, presso la Dandini. A “Parla con me”.
Aggiornamento: dalla Dandini poi sono davvero andato e la trasmissione si può vedere qui, sul sito Rai, che è un po' macchinoso e lento, ma si vede: sono una decina di minuti e iniziano dal min. 9.
C’è l’appello che invita alla veglia per il risveglio di Napoli:
mercoledì 15 dicembre, piazza del Plebiscito dalle 19 alle 20,30. Con una candela e tanto silenzio.
Che chiama ad andarci e basta. E aggiunge che è
“….perché non c’è altro da dire , ma c’è il nostro assordante silenzio che non è indifferenza! Il fatalismo di chi pensa che nulla può cambiare, nasconde spesso un vuoto di passioni e di idee che non rispecchia affatto l’indole di molti napoletani che continuano a credere di poter fare ancora qualcosa!”
Non male. Anche la simbologia, infatti, necessita ormai di un cambio..
E c’è l’appello dalle firme importanti – gli intellettuali che vogliono che Napoli abbia una speranza:
Gae Aulenti, Francesco Barbagallo, Roberto Esposito, Giuseppe Galasso, Ernesto Galli Della Loggia, Raffaele La Capria, Mario Martone, Elisabetta Rasy, Aldo Schiavone, Toni Servillo.
Leggete. Fate sapere che ne pensate.
Poi, più “politicamente”, gira l’appello a favore della candidatura di Libero Mancuso a sindaco. Che è una brava persona. Peccato – lo dico con vera tristezza - che l’appello ha un gravissimo difetto. Di rimozione. Infatti non nomina - neanche di striscio! – il fatto che la città è stata governata per ben 4 mandati dal centro-sinistra e che se sta così la nostra parte politica c’entrerà pure qualcosa! Sì, la rimozione... quella cosa lì, per la quale fa troppo dolore e fatica passare per la crudezza delle cose per uscire dalla m….
O no?
Infine un piccolo annuncio:
mercoledì sera, 8 dicembre, alle ore 23,15 sono in Tv su Rai 3, presso la Dandini. A “Parla con me”.
Aggiornamento: dalla Dandini poi sono davvero andato e la trasmissione si può vedere qui, sul sito Rai, che è un po' macchinoso e lento, ma si vede: sono una decina di minuti e iniziano dal min. 9.
29 novembre, 2010
Scuola, al Torino Film Festival
Nel week-end ho visto i documentari sulla scuola che vengono presentati al Film Festival di Torino. E ne ho scritto su La Stampa. Questo è l’articolo che è uscito oggi.
Finalmente la scuola irrompe sulla scena. E smentisce i troppi soloni che la denigrano. Così, ieri al Torino film festival si è visto il bel documentario di Marco Saltarelli: Scuola media. Il mare all’orizzonte e la potenza dell’Ilva che sprigiona fumi fanno da cornice ai ragazzini della scuola media Pirandello di Taranto che si chiedono quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un’eventuale chiusura dell’impianto siderurgico. Il grande tema della salvaguardia dell’ambiente e del come conciliarla con l’occupazione si combina con i visi dei ragazzini che si domandano della loro futura salute. E dei padri che perderebbero il lavoro. Cambia scena. E una monaca di clausura, da dietro le sbarre, parla ai ragazzini che sono andati in gita d’istruzione a trovarla. Loro le raccontano che hanno studiato i Promessi Sposi e la monaca di Monza... E lei, con voce ferma, dice loro che devono vivere in modo pieno, come ognuno può fare. E che devono farlo per scelta. E le ragazzine ascoltano. Attente. Poi, quando si allontanano, parlottano tra loro in dialetto. Fitto fitto si dicono le loro cose, le cose degli adolescenti. Di nuovo in classe una professoressa guarda oltre la prima fila e chiama a raccolta – appunto – il gruppo di adolescenti che trama dietro i primi banchi. La scuola, qui come ovunque, è il luogo d’appartenenza potente che riunisce i pari di età. Che hanno in mente e nei discorsi i loro miti, le loro storie, ben più forti delle “cose da imparare” che non hanno più l’ausilio fornito dal senso di colpa. “Vai a scuola per imparare” – ci dicevano i nostri genitori. Erano parole che funzionavano. Sia pure con le normali trasgressioni. Ma è stato eroso il patto implicito che c’era tra i nostri padri e i nostri insegnanti: ora la parola adulta non ha il retroterra di un tempo. Così i docenti devono conquistare ogni metro di attenzione a gran fatica. Convincere il gruppo di adolescenti e poi ciascun suo membro che si sta lì perché conviene imparare è la prima sfida che i docenti si pongono. Il film mostra questo. Ed è una grande faticosa opera quotidiana. Lo rivela la prof. di matematica: “la parola mia vale ogni volta di meno di quella del vostro compagno… com’è possibile?” Lo chiede a loro. E a se stessa. E’ quello che noi adulti che insegniamo ci chiediamo ogni volta. Eppure i docenti sono lì. Ogni giorno lì. Ed è come se ogni volta dicessero: va bene, capiamo, non rinunciate a essere gruppo, a essere ragazzi come siete voi e non come noi. Però fatene qualcosa. Trovate, provate, scoprite in positivo. E così le ragazzine guardano il foglio con il problema di geometria con la prof che, quasi di lato, segue i tentativi che vengono avanti. Il dettato scandito dall’altra prof. rivela una lingua obsoleta. Eppure i ragazzi scrivono, provano a tenere il passo. E le ragazzine suonano mirabilmente i violini. E un ragazzo legge le note. E dalla grammatica che sta sul pentagramma esce musica. Ed è la preside – ora si dice dirigente scolastico – che rivela quel che è davvero al centro di tutte le fatiche: dare grammatiche a ciascuno, grammatiche per leggere il mondo e starci dentro, senza le quali non si saranno cittadini. Perché senza grammatiche non ci sarà scelta.
Domani ci sarà il bellissimo film di Giulia Cederna e Angelo Loy: Una scuola italiana. Sulla scuola d’infanzia Carlo Pisacane di Roma, Tor Pignattara. Dove otto bambini su dieci sono stranieri. Le maestre lavorano con bimbi e mamme intorno al mondo del Mago di Oz e di Dorothy che vi è capitata. Non è solo la metafora della scoperta attraverso l’estraniazione. E’ il laboratorio scelto di una scuola che non solo “tiene botta” ma crea. Perché fa entrare ognuno nel mondo attraverso la porta delle emozioni e delle relazioni autentiche. La recita delle parti del Mago e del Leone, dell’Uomo di paglia e dell’Uomo di latta rapisce maestre e bambini – italiani e siriani, indiani e cinesi, latinoamericani e marocchini, del Bangladesh e del Pakistan. Lo fa mentre preserva le routine che servono a crescere: mangiare insieme, lavarsi le mani, litigare ma dire scusa e riparare, cantare “tanti auguri”, impastare e dipingere, nominare gli animali e i colori, commentare le storie altrui e raccontare le proprie. Civili, competenti, appassionate, le maestre guidono ogni passaggio e si interrogano, con commovente onestà, sui propri errori e sul senso del lavoro. E’ l’Italia migliore. Ma, intanto, fuori dall’edificio, compare - aggressivo quanto patetico - l’urlo dell’odio che chiama a sfasciare tutto questo o l’accanimento imbecille di chi deve mostrare i conflitti in tv, incapace di rispettare l’opera che si sta compiendo.
Ma forse è l’Italiano il protagonista che tiene la trama: la meravigliosa, accogliente lingua franca nella quale tutti i bimbi s’avvicinano alle loro paure, alla loro nuova casa e alla nostalgia per quella lontana, al nominare se stessi e il mondo, a dare ruotine e rito alle sante giornate. Sì, l’Italiano. Che anche le mamme vogliono imparare. Che si può imparare presto e bene. Che serve per andare in prima. In una scuola italiana.
Finalmente la scuola irrompe sulla scena. E smentisce i troppi soloni che la denigrano. Così, ieri al Torino film festival si è visto il bel documentario di Marco Saltarelli: Scuola media. Il mare all’orizzonte e la potenza dell’Ilva che sprigiona fumi fanno da cornice ai ragazzini della scuola media Pirandello di Taranto che si chiedono quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un’eventuale chiusura dell’impianto siderurgico. Il grande tema della salvaguardia dell’ambiente e del come conciliarla con l’occupazione si combina con i visi dei ragazzini che si domandano della loro futura salute. E dei padri che perderebbero il lavoro. Cambia scena. E una monaca di clausura, da dietro le sbarre, parla ai ragazzini che sono andati in gita d’istruzione a trovarla. Loro le raccontano che hanno studiato i Promessi Sposi e la monaca di Monza... E lei, con voce ferma, dice loro che devono vivere in modo pieno, come ognuno può fare. E che devono farlo per scelta. E le ragazzine ascoltano. Attente. Poi, quando si allontanano, parlottano tra loro in dialetto. Fitto fitto si dicono le loro cose, le cose degli adolescenti. Di nuovo in classe una professoressa guarda oltre la prima fila e chiama a raccolta – appunto – il gruppo di adolescenti che trama dietro i primi banchi. La scuola, qui come ovunque, è il luogo d’appartenenza potente che riunisce i pari di età. Che hanno in mente e nei discorsi i loro miti, le loro storie, ben più forti delle “cose da imparare” che non hanno più l’ausilio fornito dal senso di colpa. “Vai a scuola per imparare” – ci dicevano i nostri genitori. Erano parole che funzionavano. Sia pure con le normali trasgressioni. Ma è stato eroso il patto implicito che c’era tra i nostri padri e i nostri insegnanti: ora la parola adulta non ha il retroterra di un tempo. Così i docenti devono conquistare ogni metro di attenzione a gran fatica. Convincere il gruppo di adolescenti e poi ciascun suo membro che si sta lì perché conviene imparare è la prima sfida che i docenti si pongono. Il film mostra questo. Ed è una grande faticosa opera quotidiana. Lo rivela la prof. di matematica: “la parola mia vale ogni volta di meno di quella del vostro compagno… com’è possibile?” Lo chiede a loro. E a se stessa. E’ quello che noi adulti che insegniamo ci chiediamo ogni volta. Eppure i docenti sono lì. Ogni giorno lì. Ed è come se ogni volta dicessero: va bene, capiamo, non rinunciate a essere gruppo, a essere ragazzi come siete voi e non come noi. Però fatene qualcosa. Trovate, provate, scoprite in positivo. E così le ragazzine guardano il foglio con il problema di geometria con la prof che, quasi di lato, segue i tentativi che vengono avanti. Il dettato scandito dall’altra prof. rivela una lingua obsoleta. Eppure i ragazzi scrivono, provano a tenere il passo. E le ragazzine suonano mirabilmente i violini. E un ragazzo legge le note. E dalla grammatica che sta sul pentagramma esce musica. Ed è la preside – ora si dice dirigente scolastico – che rivela quel che è davvero al centro di tutte le fatiche: dare grammatiche a ciascuno, grammatiche per leggere il mondo e starci dentro, senza le quali non si saranno cittadini. Perché senza grammatiche non ci sarà scelta.
Domani ci sarà il bellissimo film di Giulia Cederna e Angelo Loy: Una scuola italiana. Sulla scuola d’infanzia Carlo Pisacane di Roma, Tor Pignattara. Dove otto bambini su dieci sono stranieri. Le maestre lavorano con bimbi e mamme intorno al mondo del Mago di Oz e di Dorothy che vi è capitata. Non è solo la metafora della scoperta attraverso l’estraniazione. E’ il laboratorio scelto di una scuola che non solo “tiene botta” ma crea. Perché fa entrare ognuno nel mondo attraverso la porta delle emozioni e delle relazioni autentiche. La recita delle parti del Mago e del Leone, dell’Uomo di paglia e dell’Uomo di latta rapisce maestre e bambini – italiani e siriani, indiani e cinesi, latinoamericani e marocchini, del Bangladesh e del Pakistan. Lo fa mentre preserva le routine che servono a crescere: mangiare insieme, lavarsi le mani, litigare ma dire scusa e riparare, cantare “tanti auguri”, impastare e dipingere, nominare gli animali e i colori, commentare le storie altrui e raccontare le proprie. Civili, competenti, appassionate, le maestre guidono ogni passaggio e si interrogano, con commovente onestà, sui propri errori e sul senso del lavoro. E’ l’Italia migliore. Ma, intanto, fuori dall’edificio, compare - aggressivo quanto patetico - l’urlo dell’odio che chiama a sfasciare tutto questo o l’accanimento imbecille di chi deve mostrare i conflitti in tv, incapace di rispettare l’opera che si sta compiendo.
Ma forse è l’Italiano il protagonista che tiene la trama: la meravigliosa, accogliente lingua franca nella quale tutti i bimbi s’avvicinano alle loro paure, alla loro nuova casa e alla nostalgia per quella lontana, al nominare se stessi e il mondo, a dare ruotine e rito alle sante giornate. Sì, l’Italiano. Che anche le mamme vogliono imparare. Che si può imparare presto e bene. Che serve per andare in prima. In una scuola italiana.
24 novembre, 2010
Remember monnezza?
Terribile mondezza. E sulla monnezza Berlusconi e la destra fanno schifo.
Ma c’è bisogno di un’aggiunta: siamo in pochi a poterlo dire a voce alta.
In pochi.
Perché in pochi abbiamo parlato chiaro e per tempo delle colpe di chi – il centro sinistra – ha amministrato questo territorio. Siamo stati in pochi a dirlo chiaro e ogni volta e a fare proposte sensate.
Lo so che è inelegante quanto inutile dire che uno l’aveva detto e ripetuto. Però si devono o no ricordare le cose? Quelle dette oltre tre anni fa.
O quando in molti segnalammo questo riassunto video della vicenda.
O quando c’erano da mettere insieme diversi segni inconfondibilmente legati entro un’unica brutta scena.
O quando facemmo in tanti, da diverse posizioni, questo appello realistico e forte - e tanto fece l’amministrazione da boicottare ogni anelito di cittadinanza per calcoli di quattro soldi, sindaco compreso! O quando si provava pure a scherzare per parlarne in altro modo.
O quando, stavamo a cercare una risposta civica ai giorni di Pianura, durante i quali la cupa idiozia del governo comunale si capiva, eccome.
O quando, negli stessi giorni, iniziammo l’anno con lo slogan e l’iniziativa dal basso “differenziamoci”.
O quando l’ineffabile D’Alema diceva puttanate in campagna elettorale.
O quando c’era pure il manifesto “monnezza a chi?”.
O quando più di recente, ma prima che ritornasse la monnezza per strada…
O quando…
Quante e quante volte e prove e ancora prove di sensata civile militanza positiva. Inascoltata.
Ma c’è bisogno di un’aggiunta: siamo in pochi a poterlo dire a voce alta.
In pochi.
Perché in pochi abbiamo parlato chiaro e per tempo delle colpe di chi – il centro sinistra – ha amministrato questo territorio. Siamo stati in pochi a dirlo chiaro e ogni volta e a fare proposte sensate.
Lo so che è inelegante quanto inutile dire che uno l’aveva detto e ripetuto. Però si devono o no ricordare le cose? Quelle dette oltre tre anni fa.
O quando in molti segnalammo questo riassunto video della vicenda.
O quando c’erano da mettere insieme diversi segni inconfondibilmente legati entro un’unica brutta scena.
O quando facemmo in tanti, da diverse posizioni, questo appello realistico e forte - e tanto fece l’amministrazione da boicottare ogni anelito di cittadinanza per calcoli di quattro soldi, sindaco compreso! O quando si provava pure a scherzare per parlarne in altro modo.
O quando, stavamo a cercare una risposta civica ai giorni di Pianura, durante i quali la cupa idiozia del governo comunale si capiva, eccome.
O quando, negli stessi giorni, iniziammo l’anno con lo slogan e l’iniziativa dal basso “differenziamoci”.
O quando l’ineffabile D’Alema diceva puttanate in campagna elettorale.
O quando c’era pure il manifesto “monnezza a chi?”.
O quando più di recente, ma prima che ritornasse la monnezza per strada…
O quando…
Quante e quante volte e prove e ancora prove di sensata civile militanza positiva. Inascoltata.
05 novembre, 2010
I parassiti
Mentre continua la terribile situazione della monnezza, il centro-sinistra entra nel turbinio delle manovre che tutto sono fuorché ricerca vera di risposte alle questioni che attanagliano la città.
Ma perché accade ciò? Perché prevale - rispetto alla logica dei problemi veri e del come provare a risolverli – questa logica del parlare di oggetti non intelligibili dai cittadini? Perché avviene, invariabilmente e ogni volta, che – quale che sia la condizione della città e quali che siano i tanti problemi disattesi – vi è una strenua tendenza a fare quella cosa lì che è la politica staccata dalla vita?
Ci sono molti motivi, certamente. Ma tra questi c’è che vi è una massa di persone – sufficientemente estesa, ancor più che nel resto dell’Italia – che si guadagna da vivere, appunto, facendo politica. E che non sa fare altro. E che pesa, perciò, sull’agenda, sui toni, sui ritmi, sui modi, sul lessico della politica. Si tratta, cioè, di persone che della politica hanno fatto luogo, motivo e tempo di lavoro variamente remunerato.
E’ una storia antica. Infatti il notabilato, nella tradizione del Sud – quello ben individuato da Giustino Fortunato in avanti – si è spesso composto da una quota parte di persone “capaci di tutto e buone a nulla” - piccoli e medi mestieranti delle pubbliche cose - i quali, tuttavia, avevano una qualche rendita di famiglia che forniva la base più o meno solida di una vita tranquilla. I mantenuti della politica partenopea odierni sono, invece, sempre “incapaci e incombenti” perché sono, per troppa parte, una genia di persone che non hanno mai imparato alcuna arte o che l’hanno fatta male per un certo periodo per poi dismetterla; che non sanno fare nulla e, dunque, vagano, parlano, fomentano, intrigano. Ma – rispetto alla genia analizzata dai meridionalisti classici – costoro non hanno un reddito proprio. E hanno la sola possibilità di procacciarsi reddito personale nella politica stessa. Esclusivamente. Dunque il loro agire si basa sul “creare o ricoprire spazi”, costruire pacchetti elettorali più o meno veri, prefigurare o fabbricare condizioni per un do ut des o, peggio, per ricattare e ottenere. Cosa? Un posto nel quale ottenere un buon reddito facendo politica a ogni ora del giorno. Un posto in un consiglio comunale o di municipalità, un distacco entro un ente qualsivoglia, un comando sindacale; o fare parte dello staff o dei consigli di amministrazione di aziende: municipalizzate, semi-pubbliche, private fortemente sovvenzionate, ecc. Ma – attenzione! – in una posizione laterale e protetta, dove non si deve lavorare ma “fare politica”, appunto. Un’altra cosa. Senza, cioè, dover dare conto ad alcuno che non sia il capocordata dell’appartenenza politica scelta o di un suo sottogruppo.
Queste condizioni esistenziali prive di mission e di responsabilità professionale e civile sono i loro ripari e il loro nutrimento. Si tratta, dunque, di parassiti. In senso proprio, non dispregiativo: “animale o vegetale, che vive e si nutre a spese di un altro essere vivente o ne sfrutta le risorse”. E, infatti, nella nostra vita di ogni giorno ce li troviamo a fianco lì dove noi lavoriamo e dobbiamo dare conto. Essi si individuano per questa loro funzione tacita ma altra. E ci si interroga. E non è facile la com-presenza. Perché percepiamo che noi ne garantiamo la sopravvivenza, senza volerlo. Come accade per ogni rapporto tra parassita e non parassita. E ogni volta verifichiamo, con tristezza e impotenza, che vi è tra l’una e l’altra situazione – entro gli stessi posti - una dimensione, assai complessa, fatta di opportunismi e risentimenti, sudditanze, conflitti. Proprio perché - entro gli stessi ambienti - convivono persone che fanno cose e hanno competenze e persone e parassitari taciti e accettati da troppo tempo.
Così c’è questo esercito parassitario – annidato in cento e cento anfratti e gusci accanto alle nostre vite – che ora sta entrando nella fibrillazione propria della stagione elettorale. E’ una fibrillazione non dettata da cattiveria. E il giudizio etico c’entra poco; e varia di persona in persona, come sempre. E’ una fibrillazione naturale. Perché è questo il tempo in cui questa genia difende le proprie posizioni, ogni individuo a suo modo; o aspira a una più redditizia o blocca la scena per poter agire. Tutto questo ha un risvolto che contribuisce non poco a paralizzare la città. Infatti chi non è parassita e sa fare cose, sa rispondere del proprio operare e, magari, vuole e potrebbe fare politica come effettivo impegno civile, si trova la scena occupata da chi lo impedisce .
E’ tempo che anche queste cose siano oggetto del dibattito pubblico. E forse dobbiamo ricominciare a gridare che – oltre e insieme ai poteri forti evocati nell’articolo di Sergio e Guido sulla questione dei rifiuti – vi sono i parassiti, a sinistra come a destra, che impediscono la politica. Quella vera. Perché devono sopravvivere a se stessi. Perché altro non sanno e non possono. La ripresa della città è possibile solo se si combatte contro i poteri forti, le corporazioni conservatrici e i parassiti.
Ma perché accade ciò? Perché prevale - rispetto alla logica dei problemi veri e del come provare a risolverli – questa logica del parlare di oggetti non intelligibili dai cittadini? Perché avviene, invariabilmente e ogni volta, che – quale che sia la condizione della città e quali che siano i tanti problemi disattesi – vi è una strenua tendenza a fare quella cosa lì che è la politica staccata dalla vita?
Ci sono molti motivi, certamente. Ma tra questi c’è che vi è una massa di persone – sufficientemente estesa, ancor più che nel resto dell’Italia – che si guadagna da vivere, appunto, facendo politica. E che non sa fare altro. E che pesa, perciò, sull’agenda, sui toni, sui ritmi, sui modi, sul lessico della politica. Si tratta, cioè, di persone che della politica hanno fatto luogo, motivo e tempo di lavoro variamente remunerato.
E’ una storia antica. Infatti il notabilato, nella tradizione del Sud – quello ben individuato da Giustino Fortunato in avanti – si è spesso composto da una quota parte di persone “capaci di tutto e buone a nulla” - piccoli e medi mestieranti delle pubbliche cose - i quali, tuttavia, avevano una qualche rendita di famiglia che forniva la base più o meno solida di una vita tranquilla. I mantenuti della politica partenopea odierni sono, invece, sempre “incapaci e incombenti” perché sono, per troppa parte, una genia di persone che non hanno mai imparato alcuna arte o che l’hanno fatta male per un certo periodo per poi dismetterla; che non sanno fare nulla e, dunque, vagano, parlano, fomentano, intrigano. Ma – rispetto alla genia analizzata dai meridionalisti classici – costoro non hanno un reddito proprio. E hanno la sola possibilità di procacciarsi reddito personale nella politica stessa. Esclusivamente. Dunque il loro agire si basa sul “creare o ricoprire spazi”, costruire pacchetti elettorali più o meno veri, prefigurare o fabbricare condizioni per un do ut des o, peggio, per ricattare e ottenere. Cosa? Un posto nel quale ottenere un buon reddito facendo politica a ogni ora del giorno. Un posto in un consiglio comunale o di municipalità, un distacco entro un ente qualsivoglia, un comando sindacale; o fare parte dello staff o dei consigli di amministrazione di aziende: municipalizzate, semi-pubbliche, private fortemente sovvenzionate, ecc. Ma – attenzione! – in una posizione laterale e protetta, dove non si deve lavorare ma “fare politica”, appunto. Un’altra cosa. Senza, cioè, dover dare conto ad alcuno che non sia il capocordata dell’appartenenza politica scelta o di un suo sottogruppo.
Queste condizioni esistenziali prive di mission e di responsabilità professionale e civile sono i loro ripari e il loro nutrimento. Si tratta, dunque, di parassiti. In senso proprio, non dispregiativo: “animale o vegetale, che vive e si nutre a spese di un altro essere vivente o ne sfrutta le risorse”. E, infatti, nella nostra vita di ogni giorno ce li troviamo a fianco lì dove noi lavoriamo e dobbiamo dare conto. Essi si individuano per questa loro funzione tacita ma altra. E ci si interroga. E non è facile la com-presenza. Perché percepiamo che noi ne garantiamo la sopravvivenza, senza volerlo. Come accade per ogni rapporto tra parassita e non parassita. E ogni volta verifichiamo, con tristezza e impotenza, che vi è tra l’una e l’altra situazione – entro gli stessi posti - una dimensione, assai complessa, fatta di opportunismi e risentimenti, sudditanze, conflitti. Proprio perché - entro gli stessi ambienti - convivono persone che fanno cose e hanno competenze e persone e parassitari taciti e accettati da troppo tempo.
Così c’è questo esercito parassitario – annidato in cento e cento anfratti e gusci accanto alle nostre vite – che ora sta entrando nella fibrillazione propria della stagione elettorale. E’ una fibrillazione non dettata da cattiveria. E il giudizio etico c’entra poco; e varia di persona in persona, come sempre. E’ una fibrillazione naturale. Perché è questo il tempo in cui questa genia difende le proprie posizioni, ogni individuo a suo modo; o aspira a una più redditizia o blocca la scena per poter agire. Tutto questo ha un risvolto che contribuisce non poco a paralizzare la città. Infatti chi non è parassita e sa fare cose, sa rispondere del proprio operare e, magari, vuole e potrebbe fare politica come effettivo impegno civile, si trova la scena occupata da chi lo impedisce .
E’ tempo che anche queste cose siano oggetto del dibattito pubblico. E forse dobbiamo ricominciare a gridare che – oltre e insieme ai poteri forti evocati nell’articolo di Sergio e Guido sulla questione dei rifiuti – vi sono i parassiti, a sinistra come a destra, che impediscono la politica. Quella vera. Perché devono sopravvivere a se stessi. Perché altro non sanno e non possono. La ripresa della città è possibile solo se si combatte contro i poteri forti, le corporazioni conservatrici e i parassiti.
03 novembre, 2010
Berlusconi Silvio non aiuta alcun adolescente “bisognoso”
Sabato scorso La Stampa ha pubblicato questo mio editoriale e lo riporto qui di seguito. Ho voluto dire in parole semplici, recepibili da chiunque (sì, anche da chi lo ha forse votato a Berlusconi Silvio), che il mestiere di aiutare i ragazzi è una cosa seria.
Il presidente del Consiglio ha affermato che la sua conoscenza della giovane Ruby è dovuta al fatto che egli aiuta chi ha bisogno. E la stampa e la politica si dividono tra chi crede a questa affermazione e chi pensa che si tratti di tutt’altro.
Ma forse la questione importante è soprattutto un'altra. Sì, perché sono milioni gli italiani che aiutano ragazze e ragazzi che hanno bisogno. Molti lo fanno per lavoro. A salari estremamente contenuti. Insegnanti di scuole in zone terribilmente difficili. Assistenti sociali. Psicologi. Operatori delle Asl e del privato sociale. Educatori nei centri sportivi. E, finite le ore pagate, spesso continuano a lavorare. Perché sanno che Patricia è in pericolo, che Carmine potrebbe mettersi nei guai, che Antonio va guardato a vista altrimenti ricade in errore, che la bimba di pochi mesi di Giovanna ha bisogno di pannolini. Altre volte fanno altri mestieri. Lavorano in banca. Sono imprenditori. Hanno un negozio di scarpe.
Sono operai. Eppure devolvono denari e dedicano tempo e mettono a disposizione conoscenza e attenzione emotiva e operativa. Per una casa famiglia per adolescenti in miseria o in pericolo, per un'attività di animazione di quartiere, per dare continuità a un gruppo scout che resiste in un posto difficile o una comunità per tossicodipendenti, per sostenere degli educatori di strada che raggiungono di notte e di giorno ragazzini che vagano senza un adulto di riferimento, per animare gli oratori e le altre comunità. O sono semplici genitori che fanno parte delle tante forme dell'aiuto reciproco informale che affronta crisi e pericoli della crescita. O sono esperti delle fondazioni che decidono a quali progetti dare i denari, vagliando quanto chi li gestirà saprà usarli con equilibrio e sapienza.
Sono davvero tanti gli italiani che aiutano i ragazzi, italiani e stranieri a evitare le vie difficili da cambiare. O a misurarsi con le difficoltà materiali e con gli incubi, le paure, i falsi miti, la confusione. Spesso aiutano le loro famiglie costruendo complesse misure di sostegno, rispettose degli equilibri emotivi e del diritto. Altre volte provano a ridurre i danni dell’assenza di famiglie, con l'affido o con ore e giorni di tempo dedicato. Spesso passano parte delle loro vacanze con le giovani persone povere o in difficoltà. E - per fare bene queste cose - si aggiornano sul cosa e il come fare. Studiano. Partecipano a weekend di confronto. Seguono conferenze di psicologi, pedagogisti, giudici minorili, medici. Affrontano una terapia personale o una supervisione di gruppo per evitare errori macroscopici. Vanno all'estero e si confrontano con chi fa le stesse cose altrove.
Sono credenti e laici. Votano a destra quanto al centro e a sinistra. Perché quando si tratta di fare davvero queste cose, le barriere ideologiche cadono. E il confronto, che prevede anche posizioni e indirizzi diversi, si sposta, comunque, sulla comune e difficile riflessione intorno alle cose fatte e ai risultati ottenuti o meno. E ai tanti errori. Il che richiede umiltà. E la fatica di guardarsi dentro e chiedersi: lo sto facendo per i ragazzi o per me? Ogni volta chiedersi. E sorvegliarsi. Perché educare è un mestiere difficile. Ma educare e sostenere chi è giovane e in difficoltà è difficilissimo.
Questo è il grande, laborioso esercito di persone che aiutano davvero i ragazzi che hanno bisogno. E che forse rappresentano la migliore Italia «bipartisan». Chi ne fa parte può pensare bene o male del presidente del Consiglio. Ma nessuno - proprio nessuno - ritiene che regalare gioielli e denaro e vestiti di marca a un'adolescente in difficoltà sia aiutare chi ha bisogno. Perché il solo pensarlo offende, profondamente, gli anni di lavoro, le cose fatte e apprese, lo stesso senso della vita e della relazione tra esseri umani che hanno dato significato al loro impegno.
Il presidente del Consiglio ha affermato che la sua conoscenza della giovane Ruby è dovuta al fatto che egli aiuta chi ha bisogno. E la stampa e la politica si dividono tra chi crede a questa affermazione e chi pensa che si tratti di tutt’altro.
Ma forse la questione importante è soprattutto un'altra. Sì, perché sono milioni gli italiani che aiutano ragazze e ragazzi che hanno bisogno. Molti lo fanno per lavoro. A salari estremamente contenuti. Insegnanti di scuole in zone terribilmente difficili. Assistenti sociali. Psicologi. Operatori delle Asl e del privato sociale. Educatori nei centri sportivi. E, finite le ore pagate, spesso continuano a lavorare. Perché sanno che Patricia è in pericolo, che Carmine potrebbe mettersi nei guai, che Antonio va guardato a vista altrimenti ricade in errore, che la bimba di pochi mesi di Giovanna ha bisogno di pannolini. Altre volte fanno altri mestieri. Lavorano in banca. Sono imprenditori. Hanno un negozio di scarpe.
Sono operai. Eppure devolvono denari e dedicano tempo e mettono a disposizione conoscenza e attenzione emotiva e operativa. Per una casa famiglia per adolescenti in miseria o in pericolo, per un'attività di animazione di quartiere, per dare continuità a un gruppo scout che resiste in un posto difficile o una comunità per tossicodipendenti, per sostenere degli educatori di strada che raggiungono di notte e di giorno ragazzini che vagano senza un adulto di riferimento, per animare gli oratori e le altre comunità. O sono semplici genitori che fanno parte delle tante forme dell'aiuto reciproco informale che affronta crisi e pericoli della crescita. O sono esperti delle fondazioni che decidono a quali progetti dare i denari, vagliando quanto chi li gestirà saprà usarli con equilibrio e sapienza.
Sono davvero tanti gli italiani che aiutano i ragazzi, italiani e stranieri a evitare le vie difficili da cambiare. O a misurarsi con le difficoltà materiali e con gli incubi, le paure, i falsi miti, la confusione. Spesso aiutano le loro famiglie costruendo complesse misure di sostegno, rispettose degli equilibri emotivi e del diritto. Altre volte provano a ridurre i danni dell’assenza di famiglie, con l'affido o con ore e giorni di tempo dedicato. Spesso passano parte delle loro vacanze con le giovani persone povere o in difficoltà. E - per fare bene queste cose - si aggiornano sul cosa e il come fare. Studiano. Partecipano a weekend di confronto. Seguono conferenze di psicologi, pedagogisti, giudici minorili, medici. Affrontano una terapia personale o una supervisione di gruppo per evitare errori macroscopici. Vanno all'estero e si confrontano con chi fa le stesse cose altrove.
Sono credenti e laici. Votano a destra quanto al centro e a sinistra. Perché quando si tratta di fare davvero queste cose, le barriere ideologiche cadono. E il confronto, che prevede anche posizioni e indirizzi diversi, si sposta, comunque, sulla comune e difficile riflessione intorno alle cose fatte e ai risultati ottenuti o meno. E ai tanti errori. Il che richiede umiltà. E la fatica di guardarsi dentro e chiedersi: lo sto facendo per i ragazzi o per me? Ogni volta chiedersi. E sorvegliarsi. Perché educare è un mestiere difficile. Ma educare e sostenere chi è giovane e in difficoltà è difficilissimo.
Questo è il grande, laborioso esercito di persone che aiutano davvero i ragazzi che hanno bisogno. E che forse rappresentano la migliore Italia «bipartisan». Chi ne fa parte può pensare bene o male del presidente del Consiglio. Ma nessuno - proprio nessuno - ritiene che regalare gioielli e denaro e vestiti di marca a un'adolescente in difficoltà sia aiutare chi ha bisogno. Perché il solo pensarlo offende, profondamente, gli anni di lavoro, le cose fatte e apprese, lo stesso senso della vita e della relazione tra esseri umani che hanno dato significato al loro impegno.
29 ottobre, 2010
La scuola che vorrei: collezione completa e dibattito
E' uscito il quarto (il primo è uscito il 7 settembre) e, per ora, ultimo mio articolo sull’Unità per la serie: la scuola che vorrei. E l’Unità li ha messi qui tutti ben bene in ordine. E potete anche intervenire con commenti, come molti hanno già fatto.
15 dic. Aggiornamento: non sono affatto più lì dove erano. Appena li ritrovo...
15 dic. Aggiornamento: non sono affatto più lì dove erano. Appena li ritrovo...
28 ottobre, 2010
Quale sguardo sulla monnezza
 Mentre la percentuale di raccolta differenziata scende ulteriormente a Napoli, qualche improvvido politico che ne condivide la responsabilità insiste che ci si è sforzati di fare progressi…
Mentre la percentuale di raccolta differenziata scende ulteriormente a Napoli, qualche improvvido politico che ne condivide la responsabilità insiste che ci si è sforzati di fare progressi… E’ chiaro da troppo tempo che sulla monnezza – questione che ha debilitato fino all’inverosimile lo spirito stesso della città - dobbiamo guardare anche dietro di noi per poter andare avanti. E’ sempre così quando si arriva al dunque… Tanto che sento che devo, quasi per forza di cose, in questa occasione ricordare il famoso passaggio di Walter Benjamin noto come Angelus Novus:
"C'è un quadro di Klee che s'intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è cosi forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta".
Comunque, oltre all’ottimo reportage di Napolionline (link), con riflessione di Francesco (Iacotucci) che commenta le immagini di questi giorni, sul presente suggerisco gli aggiornamenti che quotidianamente appaiono su Napoli monitor sulla crisi dei rifiuti, tra cui questo di Viola Sarnelli che racconta una nottata tra Boscoreale e Terzigno.
Consiglio, poi, quest’altra, apparsa sulla rivista “una città”, a me cara. Scritta da Guido Viale, pubblicata circa due anni fa: si possono trovare le previsioni del disastro annunciato e le responsabilità di chi in 15 anni non ha mai voluto mettere mano seriamente al problema.
Riporto, sempre da “Una città” il pezzo in cui Ugo Leone ci ha raccontato come l'area candidata a diventare la settima meraviglia della natura (il parco del Vesuvio) era stata contemporaneamente destinata ad ospitare ben due discariche per rifiuti nemmeno trattati.
13 ottobre, 2010
Segnalo che...
Per mia memoria, più che per segnalarlo a chi mi segue, faccio un piccolo elenco di cose fatte di recente.
 Ero intervenuto sulla povertà in Italia al festival nazionale di Torino a fine settembre.
Ero intervenuto sulla povertà in Italia al festival nazionale di Torino a fine settembre.
Il terzo inserto (nazioni) sui 150 anni dell’unità d’Italia, uscito con Il Manifesto del 5 ottobre ha pubblicato un mio saggio divulgativo sulla Questione meridionale (link: http://www.ilmanifesto.it/archivi/150-anni/)
Venerdì 8 ottobre ho parlato all’assemblea nazionale del Pd. Di giovani esclusi, Mezzogiorno… e quale dovrebbe essere il senso dato alla politica per la cittadinanza da un partito che si definisce democratico. Come potrete vedere non ho usato i toni solitamente in uso in tali assise…
Sabato 9 ottobre è uscito su l’Unità il mio terzo intervento sul merito di cosa può o dovrebbe essere la scuola pubblica. L’ho centrato sul riconoscimento precoce delle differenze e su un’idea larga, articolata di equità, contraria alla standardizzazione. Lo potete leggere andando alle pagine 34 e 35 dell’edizione pdf del giornale.
Per quanto riguarda la faticosa strada verso le elezioni comunali a Napoli, ho condiviso l’appello dei “cocciuti” che ostinano a pensare alla città e in più di 500 ne discutono in gruppo su FB.
E in ultimo, ma non per importanza, invito, sempre a proposito della nostra città, a visitare il sito di Simonetta – la mia amica urban sketcher che cura gli acquarelli che ogni tanto trovate qui – dove si vedono i suoi lavori, pubblicati su ANIMAls, sul sangue di S. Patrizia e la sedia di Santa Maria Francesca a Napoli; e quelli realizzati all'Aquila domenica scorsa per raccontare quello che lì (non) succede con una Carriola di disegni.
 Ero intervenuto sulla povertà in Italia al festival nazionale di Torino a fine settembre.
Ero intervenuto sulla povertà in Italia al festival nazionale di Torino a fine settembre. Il terzo inserto (nazioni) sui 150 anni dell’unità d’Italia, uscito con Il Manifesto del 5 ottobre ha pubblicato un mio saggio divulgativo sulla Questione meridionale (link: http://www.ilmanifesto.it/archivi/150-anni/)
Venerdì 8 ottobre ho parlato all’assemblea nazionale del Pd. Di giovani esclusi, Mezzogiorno… e quale dovrebbe essere il senso dato alla politica per la cittadinanza da un partito che si definisce democratico. Come potrete vedere non ho usato i toni solitamente in uso in tali assise…
Sabato 9 ottobre è uscito su l’Unità il mio terzo intervento sul merito di cosa può o dovrebbe essere la scuola pubblica. L’ho centrato sul riconoscimento precoce delle differenze e su un’idea larga, articolata di equità, contraria alla standardizzazione. Lo potete leggere andando alle pagine 34 e 35 dell’edizione pdf del giornale.
Per quanto riguarda la faticosa strada verso le elezioni comunali a Napoli, ho condiviso l’appello dei “cocciuti” che ostinano a pensare alla città e in più di 500 ne discutono in gruppo su FB.
E in ultimo, ma non per importanza, invito, sempre a proposito della nostra città, a visitare il sito di Simonetta – la mia amica urban sketcher che cura gli acquarelli che ogni tanto trovate qui – dove si vedono i suoi lavori, pubblicati su ANIMAls, sul sangue di S. Patrizia e la sedia di Santa Maria Francesca a Napoli; e quelli realizzati all'Aquila domenica scorsa per raccontare quello che lì (non) succede con una Carriola di disegni.
Iscriviti a:
Post (Atom)