Un mio articolo pubblicato su la Repubblica Napoli il 22 maggio 2015.
L'articolo con il quale Ottavio Ragone ha voluto avviare il suo lavoro di direttore di Repubblica Napoli ha esplicitato un'ispirazione, culturale e politica, quella del grande Meridionalismo.
E' una tradizione impegnativa, che inizia con le parole profetiche di Mazzini: "l'Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà". E che attraversa tutto il secolo scorso: Fortunato, Salvemini, Gramsci, Nitti, Sturzo, Dorso fino a Saraceno, Compagna, mio padre e molti altri che, insieme a migliaia di persone, hanno lavorato per il riscatto, l'innovazione, la lotta ai potentati fondati sull'interesse proprio contro quello comune e per una politica capace di guidare questa spinta.
Il Meridionalismo era fatto di persone molto diverse e che sostenevano posizioni differenti. Eppure avevano alcuni forti tratti comuni. Erano capaci di analizzare in modo rigoroso la nostra realtà entro lo scenario nazionale ed europeo. Facevano proposte bene articolate legate a persone competenti. Pensavano che il nostro riscatto non poteva avvenire con la demagogia né arrendendosi al "piangi e fotti" dei notabiliati parassitari. Non erano "élites di testimonianza" ma si impegnavano a "fare politica" coinvolgendo migliaia di insegnanti, imprenditori, funzionari pubblici, artigiani, contadini, scienziati, operai attraverso l'impegno disinteressato, anche nei partiti, nei sindacati, nell'associazionismo. Non sono mai stati "contro il Nord" ma "insieme alla parte migliore del Nord" perché ogni volta hanno cercato le possibili alleanze contro il nemico comune: la rendita.
26 maggio, 2015
10 maggio, 2015
Quando la scuola si ferma
Un mio articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa il 6/5/2015 a seguito delle proteste del mondo della scuola contro i progetti di riforma del Governo.
Quando si ferma la scuola è una cosa seria. La scuola è, infatti, un luogo che unisce molte cose: si impara il sapere dell'umanità in un tempo di radicale mutamento del come e del cosa si impara, si apprende a stare insieme tra coetanei nel mezzo di una crisi educativa generale che è di tutta la società, è il luogo della Repubblica che è più vicino alle attese e ai sentimenti di ciascuno. Sì, perché la scuola - tra bambini, ragazzi, docenti e altri lavoratori - comprende 9 milioni di persone; e, intorno - tra genitori, nonni e altri - almeno altri 20 milioni. Luogo di speranza e artigianale costruzione, di grande inclusione, di dolorose esclusioni, di meravigliose innovazioni fatte da docenti straordinari, di conservazioni inaccettabili e anche di docenze mediocri.
E' per questo e per tanto altro ancora che tutto ricomincia a muovere le menti e i sentimenti quando il tema è la scuola. Esercitare scelte riguardanti la scuola, in modo democratico, non è facile. Ci vogliono processi ben sorvegliati. E' certo che non tutti possono essere sempre d'accordo. Ma è pur vero che se così tanti - e così diversi tra loro - sono contro una proposta che riguarda la trasformazione della scuola bisogna dare ascolto - per il bene stesso del processo di cambiamento - e riflettere perché, evidentemente, il processo non è andato come poteva.
Quando si ferma la scuola è una cosa seria. La scuola è, infatti, un luogo che unisce molte cose: si impara il sapere dell'umanità in un tempo di radicale mutamento del come e del cosa si impara, si apprende a stare insieme tra coetanei nel mezzo di una crisi educativa generale che è di tutta la società, è il luogo della Repubblica che è più vicino alle attese e ai sentimenti di ciascuno. Sì, perché la scuola - tra bambini, ragazzi, docenti e altri lavoratori - comprende 9 milioni di persone; e, intorno - tra genitori, nonni e altri - almeno altri 20 milioni. Luogo di speranza e artigianale costruzione, di grande inclusione, di dolorose esclusioni, di meravigliose innovazioni fatte da docenti straordinari, di conservazioni inaccettabili e anche di docenze mediocri.
E' per questo e per tanto altro ancora che tutto ricomincia a muovere le menti e i sentimenti quando il tema è la scuola. Esercitare scelte riguardanti la scuola, in modo democratico, non è facile. Ci vogliono processi ben sorvegliati. E' certo che non tutti possono essere sempre d'accordo. Ma è pur vero che se così tanti - e così diversi tra loro - sono contro una proposta che riguarda la trasformazione della scuola bisogna dare ascolto - per il bene stesso del processo di cambiamento - e riflettere perché, evidentemente, il processo non è andato come poteva.
26 marzo, 2015
Un "normale" martedì di marzo
Un mio articolo scritto dopo alcune scene impressionanti avvenute nella periferia est della città e pubblicato su Repubblica Napoli il 25 Marzo.
E’ un normale martedì di marzo. Ma è un tempo di seria riflessione per la nostra città.
Ponticelli. Le telecamere dei carabinieri riprendono una strada per vari mesi. Lo si capisce dagli abiti delle persone riprese. Prima calzoncini e magliette. Poi abiti invernali. Sono scene che si ripetono nel tempo. E’ un luogo dove non vi è la legge. Non è un singolo episodio. E’ la ripetizione nel tempo che colpisce. Con una normalità della scena, una consuetudine nei gesti. Il monopolio della forza sul quale si basa ogni stato di diritto è evidentemente eclissato. La via è in mano, mese dopo mese, episodio dopo episodio, a bande, giovanissime, che vengono, vanno, ritornano. Gli abitanti sono terrorizzati.
I giudici, i carabinieri, i funzionari della Questura ripetono che non sembra l’Italia. Lo ripetono con voce misurata e affaticata, in modo accorato, dolorante. Colpisce che dicano questo dopo avere appena arrestato oltre 60 persone di tre diversi clan. Non cantano affatto vittoria. Non minimizzano, non sono soddisfatti. Molti degli arrestati sono giovanissimi. Giudici e forze dell’ordine parlano con toni preoccupatissimi. Dicono che si deve fare molto di più. Chiamano a una nuova stagione di impegno straordinario tutte le istituzioni e la nostra comunità. Hanno ragione.
Dobbiamo fermarci a capire cosa sta succedendo. Guardo queste scene sullo schermo con gli amici che lavorano da anni in questi quartieri, insegnanti, operatori del sociale che hanno, nel tempo, costruito una conoscenza, una competenza straordinaria, unica in Italia.
E’ un normale martedì di marzo. Ma è un tempo di seria riflessione per la nostra città.
Ponticelli. Le telecamere dei carabinieri riprendono una strada per vari mesi. Lo si capisce dagli abiti delle persone riprese. Prima calzoncini e magliette. Poi abiti invernali. Sono scene che si ripetono nel tempo. E’ un luogo dove non vi è la legge. Non è un singolo episodio. E’ la ripetizione nel tempo che colpisce. Con una normalità della scena, una consuetudine nei gesti. Il monopolio della forza sul quale si basa ogni stato di diritto è evidentemente eclissato. La via è in mano, mese dopo mese, episodio dopo episodio, a bande, giovanissime, che vengono, vanno, ritornano. Gli abitanti sono terrorizzati.
I giudici, i carabinieri, i funzionari della Questura ripetono che non sembra l’Italia. Lo ripetono con voce misurata e affaticata, in modo accorato, dolorante. Colpisce che dicano questo dopo avere appena arrestato oltre 60 persone di tre diversi clan. Non cantano affatto vittoria. Non minimizzano, non sono soddisfatti. Molti degli arrestati sono giovanissimi. Giudici e forze dell’ordine parlano con toni preoccupatissimi. Dicono che si deve fare molto di più. Chiamano a una nuova stagione di impegno straordinario tutte le istituzioni e la nostra comunità. Hanno ragione.
Dobbiamo fermarci a capire cosa sta succedendo. Guardo queste scene sullo schermo con gli amici che lavorano da anni in questi quartieri, insegnanti, operatori del sociale che hanno, nel tempo, costruito una conoscenza, una competenza straordinaria, unica in Italia.
29 gennaio, 2015
La scuola è mondo
 Quest’estate ci siamo presi il tempo per una lunga conversazione, l’abbiamo registrata e ci abbiamo lavorato su. Ed eccoci qui, finalmente!
Quest’estate ci siamo presi il tempo per una lunga conversazione, l’abbiamo registrata e ci abbiamo lavorato su. Ed eccoci qui, finalmente!Il 4 febbraio arriva in libreria “La scuola è mondo. Conversazioni su strada e istituzioni” (Edizioni Gruppo Abele). Si parla di scuola. Ma si parla soprattutto dei modi dell’apprendimento, del mondo che cambia e delle nuove sfide educative che l’Italia ha di fronte. E di innovazione sociale, buona politica e vari altri aspetti della vita umana…
07 gennaio, 2015
Il suo blues oltre le generazioni
Un mio articolo sulla scomparsa di Pino Daniele, apparso su La Stampa del 6/1/2015.
Due cose a Napoli sono come i venti che vengono dal mare, che cambiano ma restano eterni: la musica e il teatro. Quando muore un teatrante o un musicista di Napoli, qui è lutto vero.
I funerali di Pino Daniele non sono a Napoli. Se lo fossero, si sarebbero riempite le vie di un popolo di ogni età che, all’ora data, sarebbe “sceso” - come si dice qui. Ma il tributo intenso, universale a Pino c’è. Da ieri mattina i negozi e i bar, i ristoranti e gli ambulanti con le radio accese, le strade riempite per i saldi e le stazioni del metrò risuonano del suono di Pino. Le persone si fermano, commentano i testi che riempiono l’aria gelata, che ognuno conosce strofa per strofa, senza omissioni, e canticchiano e ricordano. La gente parla di lui, dei suoi concerti, del primo disco comprato, dei figli che collezionano i dischi. I bambini ascoltano i genitori e sanno di cosa si sta parlando, senza bisogno di spiegazioni. Su skype e su facebook le decine di migliaia di ragazzi e ragazze andati lontani per studio o per lavoro, si collegano, chiedono “che si dice” nella loro città. Da fuori si sa com’è in questi momenti; e ci si sente più lontano e più vicino. Ogni incontro oggi per strada inizia con Pino, prima ancora del saluto. Quartiere per quartiere. E’ tutto così.
Due cose a Napoli sono come i venti che vengono dal mare, che cambiano ma restano eterni: la musica e il teatro. Quando muore un teatrante o un musicista di Napoli, qui è lutto vero.
I funerali di Pino Daniele non sono a Napoli. Se lo fossero, si sarebbero riempite le vie di un popolo di ogni età che, all’ora data, sarebbe “sceso” - come si dice qui. Ma il tributo intenso, universale a Pino c’è. Da ieri mattina i negozi e i bar, i ristoranti e gli ambulanti con le radio accese, le strade riempite per i saldi e le stazioni del metrò risuonano del suono di Pino. Le persone si fermano, commentano i testi che riempiono l’aria gelata, che ognuno conosce strofa per strofa, senza omissioni, e canticchiano e ricordano. La gente parla di lui, dei suoi concerti, del primo disco comprato, dei figli che collezionano i dischi. I bambini ascoltano i genitori e sanno di cosa si sta parlando, senza bisogno di spiegazioni. Su skype e su facebook le decine di migliaia di ragazzi e ragazze andati lontani per studio o per lavoro, si collegano, chiedono “che si dice” nella loro città. Da fuori si sa com’è in questi momenti; e ci si sente più lontano e più vicino. Ogni incontro oggi per strada inizia con Pino, prima ancora del saluto. Quartiere per quartiere. E’ tutto così.
07 novembre, 2014
E Marianna scoprì il numero pazzo
"I bambini pensano grande. Cronaca di un'avventura pedagogica." (Sellerio editore, Palermo, 2014). Il maestro elementare Franco Lorenzoni spiega in un libro come insegnare “dando il tempo di perdere tempo”. La mia recensione apparsa il 7 Novembre 2014 sul quotidiano La Stampa.
C’è un frammento di Senofane. Gli dei non svelarono agli uomini tutti i segreti:
sono migliori gli esiti di una ricerca lunga. E’ a questo frammento che ho pensato dopo avere letto e riletto il libro del mio amico Franco Lorenzoni.
Un gruppo di alunni di V elementare vogliono misurare l’altezza del castello del loro antico borgo. Il maestro li aiuta a viaggiare nel tempo, all’origine del nostro comune sapere. Scoprono che Talete, duemilaseicento anni fa, durante un viaggio in Egitto, aveva trovato il modo di misurare l’altezza della piramide di Cheope usando l’ombra. Così - mentre studiano l’Egitto antico e il perché era così importante misurare la terra lungo il Nilo e anche come si calcola il passaggio del tempo da allora ad oggi – misurano a gruppi le loro altezze e quelle delle loro ombre alle diverse ore del giorno. Trovano l’ora esatta nella quale le loro ombre sono la metà dell’altezza di ognuno. Poi misurano l’ombra del castello all’ora giusta stabilendone l’altezza. Imparano la geometria così. Come fu originata, sulle orme di una grande maestra della scuola pubblica italiana, Emma Castelnuovo, “dando il tempo di perdere tempo”.
C’è un frammento di Senofane. Gli dei non svelarono agli uomini tutti i segreti:
sono migliori gli esiti di una ricerca lunga. E’ a questo frammento che ho pensato dopo avere letto e riletto il libro del mio amico Franco Lorenzoni.
Un gruppo di alunni di V elementare vogliono misurare l’altezza del castello del loro antico borgo. Il maestro li aiuta a viaggiare nel tempo, all’origine del nostro comune sapere. Scoprono che Talete, duemilaseicento anni fa, durante un viaggio in Egitto, aveva trovato il modo di misurare l’altezza della piramide di Cheope usando l’ombra. Così - mentre studiano l’Egitto antico e il perché era così importante misurare la terra lungo il Nilo e anche come si calcola il passaggio del tempo da allora ad oggi – misurano a gruppi le loro altezze e quelle delle loro ombre alle diverse ore del giorno. Trovano l’ora esatta nella quale le loro ombre sono la metà dell’altezza di ognuno. Poi misurano l’ombra del castello all’ora giusta stabilendone l’altezza. Imparano la geometria così. Come fu originata, sulle orme di una grande maestra della scuola pubblica italiana, Emma Castelnuovo, “dando il tempo di perdere tempo”.
30 settembre, 2014
Campania: rispondere alle attese di buona politica
Questo articolo è stato pubblicato su La Repubblica di Napoli il giorno 30 Settembre.
Sono giornate di ripresa e di turbolenza politica. E non è facile orientarsi.
La vicenda giudiziaria che riguarda il Sindaco di Napoli è venuta proprio nel momento in cui iniziavano a scaldarsi i motori in vista delle elezioni del consiglio metropolitano ma soprattutto della lunga campagna per la guida della regione.
La reazione del Sindaco alla vicenda che l’ha coinvolto è disarmante. Insomma, si sa: le regole possono non essere le migliori; però, una volta date, lo sono per tutti; e lo sono di più per chi ha maggiori responsabilità. Questa è la loro natura, la loro sintassi. Parlare di regole esattamente in questo modo – come ha sempre fatto, con enfasi, il Sindaco - salvo poi smentire questa linea, con toni smaccatamente anti-istituzionali, quando capita a lui, è smentire la sintassi stessa. Per il posto che ricopre (e anche non volendo considerare la sua storia e le sue posizioni pubbliche su analoghe vicende), Luigi de Magistris era chiamato a rispettare i modi e i toni che sono confacenti alle responsabilità istituzionali che riguardano la guida della terza città d’Italia. Non l’ha fatto. Perciò, sulla vicenda in sé, vi è ormai poco da dire. Perché ha detto lui da solo che il suo orizzonte è fuori dalla responsabilità pubblica.
La cosa, però, assume una forte valenza negativa per i cittadini, ben oltre quel che avverrà al sindaco: sospensione, dimissioni o lento tira e molla.
10 settembre, 2014
Micromega
E' in edicola Micromega n. 6/2014, un numero monografico dedicato alla scuola. All'interno c'è un mio contributo sul fallimento formativo, di cui riporto un piccolo estratto introduttivo.
"Poiché è onesto esplicitare da quale punto di vista si guardano i fatti, le posizioni dalle quali guardo la “dispersione scolastica” – che è meglio chiamare “fallimento formativo” - sono più d’una. Ho insegnato nelle scuole primarie in Italia e all’estero e perciò ho esperienza diretta di più modelli di scuola; ho fatto l’educatore sociale mentre facevo l’insegnante e ho imparato a riconoscere, nel concreto, che apprendere è cosa “ben più larga” di imparare a scuola; mi sono occupato di una scuola di seconda opportunità e ho a lungo lavorato, dunque, con ragazzi già fuori dalla scuola mettendo alla prova un modello di apprendimento più flessibile e a misura di ciascuno, sempre pubblico ma “altro e diverso” - così come raccomanda la Convenzione dei diritti dei bambini di New York e come ha indicato già Jacques Delors all’avvio dell’Unione Europea ; ho, nel tempo, riconosciuto che non basta “riportare alla scuola così com’è” per riconquistare chi è già fuori dal diritto all’istruzione e che, d’altra parte, la scuola così com’è contiene un forte eccesso di standardizzazione che è con-causa dei fenomeni di “caduta fuori”/droping-out dalla scuola ; ho avuto la possibilità di guardare al sistema scolastico nel suo insieme e non solo da dentro l’esperienza operante, potendo esaminare la grande complessità dei dati che mostrano i punti di tenuta e di innovazione ma anche i molti limiti del nostro sistema; ho potuto avere il punto di osservazione di chi, insieme ad altri e entro i processi istituzionali, contribuisce alle politiche pubbliche.
Qui vorrei esplicitare, in particolare, due punti di vista dai quali continuo, testardamente, a guardare al fallimento formativo i quali – credo – abbiano sia una connotazione etica e di diritto pubblico che politica. La prima proviene da don Milani. Che ha avuto, per tanti della mia generazione, un’importanza decisiva per come si guarda al mondo e anche per le scelte personali e che, quaranta anni fa, mi ha, in qualche modo, spinto a fare il maestro e a farlo prevalentemente nei luoghi delle povertà educative, luoghi ai quali sono ora tornato, dopo l’esperienza di Sottosegretario di Stato all’Istruzione, con delega anche per la dispersione scolastica. [...]"
Continua su Micromega n. 6/2014
"Poiché è onesto esplicitare da quale punto di vista si guardano i fatti, le posizioni dalle quali guardo la “dispersione scolastica” – che è meglio chiamare “fallimento formativo” - sono più d’una. Ho insegnato nelle scuole primarie in Italia e all’estero e perciò ho esperienza diretta di più modelli di scuola; ho fatto l’educatore sociale mentre facevo l’insegnante e ho imparato a riconoscere, nel concreto, che apprendere è cosa “ben più larga” di imparare a scuola; mi sono occupato di una scuola di seconda opportunità e ho a lungo lavorato, dunque, con ragazzi già fuori dalla scuola mettendo alla prova un modello di apprendimento più flessibile e a misura di ciascuno, sempre pubblico ma “altro e diverso” - così come raccomanda la Convenzione dei diritti dei bambini di New York e come ha indicato già Jacques Delors all’avvio dell’Unione Europea ; ho, nel tempo, riconosciuto che non basta “riportare alla scuola così com’è” per riconquistare chi è già fuori dal diritto all’istruzione e che, d’altra parte, la scuola così com’è contiene un forte eccesso di standardizzazione che è con-causa dei fenomeni di “caduta fuori”/droping-out dalla scuola ; ho avuto la possibilità di guardare al sistema scolastico nel suo insieme e non solo da dentro l’esperienza operante, potendo esaminare la grande complessità dei dati che mostrano i punti di tenuta e di innovazione ma anche i molti limiti del nostro sistema; ho potuto avere il punto di osservazione di chi, insieme ad altri e entro i processi istituzionali, contribuisce alle politiche pubbliche.
Qui vorrei esplicitare, in particolare, due punti di vista dai quali continuo, testardamente, a guardare al fallimento formativo i quali – credo – abbiano sia una connotazione etica e di diritto pubblico che politica. La prima proviene da don Milani. Che ha avuto, per tanti della mia generazione, un’importanza decisiva per come si guarda al mondo e anche per le scelte personali e che, quaranta anni fa, mi ha, in qualche modo, spinto a fare il maestro e a farlo prevalentemente nei luoghi delle povertà educative, luoghi ai quali sono ora tornato, dopo l’esperienza di Sottosegretario di Stato all’Istruzione, con delega anche per la dispersione scolastica. [...]"
Continua su Micromega n. 6/2014
08 settembre, 2014
Un sussulto per il rione martoriato
Un mio articolo apparso su La Stampa del 7 Settembre sulla tragica morte di Davide Bifolco e sulle risposte della politica verso chi cresce nei rioni di Napoli.
Davide Bifolco era poco più che un bambino. Morire così a diciassette anni è terribile. Il dolore dei genitori, dei fratelli e degli amici è terribile. Lo smarrimento di tanti insegnanti, educatori, mister dei campetti di periferia, volontari, parroci, assistenti sociali impegnati ogni giorno in città è grande in queste ore. E la città tutta intera tocca ancora una volta le sue ferite.
Non è proprio il caso di fare ipotesi su come è andata. E’ bene tacere e aspettare le indagini. Certo, un ragazzino non può morire così. Non è ammissibile.
Ma sulla scena che sta intorno a questo strazio non si deve tacere. E per chi non è di Napoli va raccontata questa scena.
Davide Bifolco era poco più che un bambino. Morire così a diciassette anni è terribile. Il dolore dei genitori, dei fratelli e degli amici è terribile. Lo smarrimento di tanti insegnanti, educatori, mister dei campetti di periferia, volontari, parroci, assistenti sociali impegnati ogni giorno in città è grande in queste ore. E la città tutta intera tocca ancora una volta le sue ferite.
Non è proprio il caso di fare ipotesi su come è andata. E’ bene tacere e aspettare le indagini. Certo, un ragazzino non può morire così. Non è ammissibile.
Ma sulla scena che sta intorno a questo strazio non si deve tacere. E per chi non è di Napoli va raccontata questa scena.
27 agosto, 2014
Cosa si chiede a una scuola moderna
Sono giorni in cui si parla di nuovo e molto di scuola e di possibili novità in arrivo. Oggi 27 Agosto La Stampa pubblica una mia riflessione su ciò che si chiede a una scuola moderna. A partire dai ragazzi e dal migliore lavoro dei docenti.
"Il Presidente del Consiglio fa molto bene a ripetere che il futuro dell’Italia è determinato dal futuro delle nostre scuole. Si vedrà quel che sarà fatto, a partire dal prossimo Consiglio dei Ministri. Ma, intanto, una cosa è certa: sono finiti gli anni cupi del disinvestimento in istruzione, nei quali la nostra scuola - a differenza di tutti i paesi OCSE e di tutte le stagioni della nostra stessa storia nazionale - veniva considerata una zavorra anziché il più importante degli investimenti.
Ma quale scuola serve per il futuro?
Per rispondere è davvero importante partire dai ragazzi. E dal migliore lavoro dei docenti. E da come le due principali risorse della scuola hanno saputo rispondere al lungo stallo italiano e poi alla crisi. [...] "
L'articolo integrale qui.
"Il Presidente del Consiglio fa molto bene a ripetere che il futuro dell’Italia è determinato dal futuro delle nostre scuole. Si vedrà quel che sarà fatto, a partire dal prossimo Consiglio dei Ministri. Ma, intanto, una cosa è certa: sono finiti gli anni cupi del disinvestimento in istruzione, nei quali la nostra scuola - a differenza di tutti i paesi OCSE e di tutte le stagioni della nostra stessa storia nazionale - veniva considerata una zavorra anziché il più importante degli investimenti.
Ma quale scuola serve per il futuro?
Per rispondere è davvero importante partire dai ragazzi. E dal migliore lavoro dei docenti. E da come le due principali risorse della scuola hanno saputo rispondere al lungo stallo italiano e poi alla crisi. [...] "
L'articolo integrale qui.
26 luglio, 2014
Con l’altro davanti
 |
| E' in libreria "Con l'altro davanti" (ed. Libreria Universitaria) |
Da molti anni ho ripreso a interrogarmi sul significato degli incontri umani – di tutti gli incontri umani, ben oltre la scuola - coma base dell’apprendere e dell’educare. Questo lavoro sui fondamenti mi aveva portato, sette anni fa, anche a riprendere gli studi universitari dopo troppe interruzioni. Ero intenzionato a capirne di più, iscrivendomi alla Pontificia Università Salesiana ma soprattutto leggendo intensamente e con metodo sul tema. Avevo anche un grande bisogno di parlarne in modo libero da schemi e facili conclusioni e, dunque, con una persona e una ricercatrice che, proprio su questo tema, ne sapesse davvero tanto. E’ così che ho costruito una serie di lunghe “sedute di conversazione” con Clotilde Pontecorvo, mia cara amica e maestra; sedute di intervista-conversazione che sono state il centro, poi, anche della mia tesi di laurea.
Clotilde è professore emerito di psicologia dell’educazione dell’università la Sapienza di Roma. Docente universitario di vasta cultura filosofica, pedagogica e psicologica, ha sempre lavorato a contatto con le scuole e gli insegnanti. Membro ascoltato di molti organismi istituzionali, è impegnata da decenni per l’innovazione della scuola pubblica, la formazione dei docenti, l’accurata costruzione dei contesti di apprendimento e la centralità dei temi educativi nella società contemporanea. Ricercatrice di profilo internazionale, ha scritto e curato una ventina di volumi e più di 230 articoli e monografie, dedicati, in particolare, alla complessità dei processi socio-cognitivi, ai contenuti e alla didattica soprattutto di area umanistica e alle interazioni discorsive tra le generazioni a scuola e in famiglia.
Nel conversare con Clotilde sono partito dalla nota affermazione di Martin Buber: “Ogni vita vera è incontro”. Da qui è nato un dialogo molto appassionato che interroga il senso e le prospettive del dialogo stesso. E che è andato avanti e indietro tra la vicenda biografica di Clotilde, la storia degli studi e delle ricerche sul tema, le diverse prospettive e i grandi quesiti intorno alla nozione di altro che attraversano più tradizioni, da quella ebraica a quella cristiana a quella del tempo dei lumi a quella che è a fondamento, con Socrate, della filosofia antica.
Per chi si occupa di scuola e di educazione è un libro che prova anche a mostrare come la ricerca in campo psicologico, pedagogico e delle neuroscienze oggi attesti che il riconoscimento dell’altro sia alla base dell’apprendimento umano.
Per me che c’ho lavorato ne è venuto una sorta di nuovo richiamo all'altro come fondamento, ancora oggi, della possibilità di vivere e operare insieme per la polis.
24 luglio, 2014
Da tutto il mondo
L’altro ieri (22 luglio) sono andato all’incontro di 400 maestre e maestri provenienti da tutto il mondo. Maestri spesso di bambini poveri, in piccole scuole lontane dai grandi centri (come nella foto) o in scuole piene di bambini e bambine nelle metropoli gigantesche del modo. Sono i maestri che si sono formati e che si ispirano alla pedagogia di Celestin Freinet e della cooperazione educativa. Alla quale mi sono formato quando ho iniziato a insegnare.
Dal 21 al 30 luglio si riuniscono a Reggio Emilia. E lavorano. Tanto e bene. Basta guardare un attimo i soli titoli dei molti laboratori. Sì, solo i titoli dei laboratori formativi - guardate qui, per favore ci dicono di mondi, di tempo dedicato, di vero confronto tra persone che fanno lo stesso mestiere a migliaia di chilometri di distanza, in contesti diversissimi, eppure….
Tanto ma tanto materiale prezioso, costruito da persone dedicate e capaci e sul merito delle cose. Quanto ci vorrebbe più tempo e pensieri dedicati a queste cose, in questo Paese...
Dal 21 al 30 luglio si riuniscono a Reggio Emilia. E lavorano. Tanto e bene. Basta guardare un attimo i soli titoli dei molti laboratori. Sì, solo i titoli dei laboratori formativi - guardate qui, per favore ci dicono di mondi, di tempo dedicato, di vero confronto tra persone che fanno lo stesso mestiere a migliaia di chilometri di distanza, in contesti diversissimi, eppure….
Tanto ma tanto materiale prezioso, costruito da persone dedicate e capaci e sul merito delle cose. Quanto ci vorrebbe più tempo e pensieri dedicati a queste cose, in questo Paese...
12 luglio, 2014
Quelle barriere che separano le persone dalla bellezza
Questo che segue è il mio articolo uscito su Repubblica Napoli di oggi a commento dell’intollerabile morte di Salvatore Giordano, ragazzo di 14 anni colpito da una pietra caduta da un cornicione storico nel centro monumentale della sua città, vittima innocente della perenne incuria della città di Napoli, ora tutta transennata. E segno di irresponsabilità degli adulti, incapaci di lasciare alle future generazioni i luoghi curati e manutenuti come dovrebbe avvenire in ogni comunità umana.
Sciama il vento di maestrale. La pioggia che è passata ha ridato nitidezza a S. Martino, a Capodimonte, alle centinaia di palazzi messi uno accanto all'altro con maestria, nei secoli; e ridà luce al golfo, che viene incontro com'è ritratto nei quadri ammirati nei grandi musei di Vienna, di Londra, di Parigi, di San Pietroburgo. I dipinti dei migliori pittori d’Europa che volevano mostrare ovunque una delle città più belle al mondo. Da sempre vista così.
Ma in questi giorni così luminosi i turisti che continuano a venire per ammirarci e i cittadini di Napoli sono messi a distanza dai luoghi. Crescono le barriere tra le persone e le bellezze. Ovunque. E ora nel centro monumentale. Il palazzo reale è transennato e vi si accede da un lato che il gruppo dei turisti, uscito estasiato dalla metropolitana, non può trovare. In via Toledo altre transenne impediscono l’ingresso in Galleria. E altre ancora stanno davanti al S. Carlo. Le persone passano, commentano, sentono la città come in una specie di assidua quarantena. Si dispiacciono. Per Salvatore. Per i luoghi deperiti e resi un pericolo. La ragazza napoletana che parla un buon inglese cerca di spiegare alla coppia salita dal porto con la guida in mano che è un’emergenza, che c’è pericolo. La giovane coppia dice che non capisce. La ragazza risponde loro - con un sorriso di vergogna dignitosa - che neanche lei capisce. E ha ragione.
Sciama il vento di maestrale. La pioggia che è passata ha ridato nitidezza a S. Martino, a Capodimonte, alle centinaia di palazzi messi uno accanto all'altro con maestria, nei secoli; e ridà luce al golfo, che viene incontro com'è ritratto nei quadri ammirati nei grandi musei di Vienna, di Londra, di Parigi, di San Pietroburgo. I dipinti dei migliori pittori d’Europa che volevano mostrare ovunque una delle città più belle al mondo. Da sempre vista così.
Ma in questi giorni così luminosi i turisti che continuano a venire per ammirarci e i cittadini di Napoli sono messi a distanza dai luoghi. Crescono le barriere tra le persone e le bellezze. Ovunque. E ora nel centro monumentale. Il palazzo reale è transennato e vi si accede da un lato che il gruppo dei turisti, uscito estasiato dalla metropolitana, non può trovare. In via Toledo altre transenne impediscono l’ingresso in Galleria. E altre ancora stanno davanti al S. Carlo. Le persone passano, commentano, sentono la città come in una specie di assidua quarantena. Si dispiacciono. Per Salvatore. Per i luoghi deperiti e resi un pericolo. La ragazza napoletana che parla un buon inglese cerca di spiegare alla coppia salita dal porto con la guida in mano che è un’emergenza, che c’è pericolo. La giovane coppia dice che non capisce. La ragazza risponde loro - con un sorriso di vergogna dignitosa - che neanche lei capisce. E ha ragione.
01 luglio, 2014
Dare forza ai potenziali di cambiamento positivi
Un mio articolo apparso sulla Newsletter Nuovi Lavori n. 135 del 24 Giugno 2014 dedicata al tema: "Perchè il Mezzogiorno non si ribella?".
Più che domandarsi perché il Sud non si ribella all’evidenza del declino economico e della marginalità prolungata (pre-esistenti a questa crisi ma da essa aggravati) - che continua a escluderne i cittadini, più che altrove, dalle opportunità e dai diritti civili e sociali - conviene, forse, ritornare a indagare i fattori di cambiamento e quelli di conservazione che convivono sulla scena del Mezzogiorno.
Con uno sguardo a ritroso e uno sull’oggi.
C’è un passaggio della storia del Mezzogiorno al quale, nella riflessione comune, è importante tornare. L’Italia è una Repubblica grazie alla vittoria del referendum costituzionale. Ebbene, quella vittoria ci fu anche grazie al compatto e non scontato voto repubblicano dei contadini e dei braccianti meridionali. La parte più povera, dunque, della società meridionale si rivelò essere fortemente dinamica in un passaggio decisivo. E fu dinamica nonostante due decenni terribili, vissuti proprio da questa parte della popolazione più esclusa dai diritti e dalle opportunità.
Ricordiamolo. Tra il 1926 e il 1941 - mentre vi fu un nuovo aumento demografico più rapido di quello del Nord - la recessione mondiale e la sua gestione da parte del regime fascista imposero la riduzione dei salari agricoli a sostegno dei latifondisti e fecero crollare i prezzi in agricoltura che allora contribuiva per il 70% alla formazione del reddito meridionale. E, intanto, si arrestarono l’emigrazione verso l’America e il flusso delle rimesse degli emigranti, colpiti dalla chiusura all’emigrazione italiana del 1921 e, poi, dalla grande crisi del 1929. Così, la disoccupazione di massa e la miseria investirono soprattutto contadini e braccianti. E non bastarono ad arginarle né l’arruolamento nelle guerre di Spagna e d’Etiopia né le lente politiche delle opere pubbliche (limitata bonifica, estensione delle reti stradali, lavori nelle città), né le fragili protezioni sociali (prima previdenza, piccolo imponibile di mano d’opera). Quel Mezzogiorno legato alla terra e stremato dalla miseria fu portato a conoscenza del grande pubblico italiano e mondiale dal Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi.
Più che domandarsi perché il Sud non si ribella all’evidenza del declino economico e della marginalità prolungata (pre-esistenti a questa crisi ma da essa aggravati) - che continua a escluderne i cittadini, più che altrove, dalle opportunità e dai diritti civili e sociali - conviene, forse, ritornare a indagare i fattori di cambiamento e quelli di conservazione che convivono sulla scena del Mezzogiorno.
Con uno sguardo a ritroso e uno sull’oggi.
C’è un passaggio della storia del Mezzogiorno al quale, nella riflessione comune, è importante tornare. L’Italia è una Repubblica grazie alla vittoria del referendum costituzionale. Ebbene, quella vittoria ci fu anche grazie al compatto e non scontato voto repubblicano dei contadini e dei braccianti meridionali. La parte più povera, dunque, della società meridionale si rivelò essere fortemente dinamica in un passaggio decisivo. E fu dinamica nonostante due decenni terribili, vissuti proprio da questa parte della popolazione più esclusa dai diritti e dalle opportunità.
Ricordiamolo. Tra il 1926 e il 1941 - mentre vi fu un nuovo aumento demografico più rapido di quello del Nord - la recessione mondiale e la sua gestione da parte del regime fascista imposero la riduzione dei salari agricoli a sostegno dei latifondisti e fecero crollare i prezzi in agricoltura che allora contribuiva per il 70% alla formazione del reddito meridionale. E, intanto, si arrestarono l’emigrazione verso l’America e il flusso delle rimesse degli emigranti, colpiti dalla chiusura all’emigrazione italiana del 1921 e, poi, dalla grande crisi del 1929. Così, la disoccupazione di massa e la miseria investirono soprattutto contadini e braccianti. E non bastarono ad arginarle né l’arruolamento nelle guerre di Spagna e d’Etiopia né le lente politiche delle opere pubbliche (limitata bonifica, estensione delle reti stradali, lavori nelle città), né le fragili protezioni sociali (prima previdenza, piccolo imponibile di mano d’opera). Quel Mezzogiorno legato alla terra e stremato dalla miseria fu portato a conoscenza del grande pubblico italiano e mondiale dal Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi.
30 giugno, 2014
Un evento civile per unire il Paese
L'articolo a mia firma pubblicato su Repubblica Napoli il 28 giugno. Una riflessione sulla violenza negli stadi nel giorno dei funerali di Ciro Esposito.
La folla di Scampia che ha accompagnato Ciro Esposito, riunendo tutta Napoli e anche tanti pezzi d’Italia, è un evento civile di rilevanza nazionale.
Sì, nazionale.
Perché quando una folla di migliaia di persone e di tantissimi ragazzi e ragazze di una città ferita piange, in modo così composto, senza proteste né rivendicazioni, un proprio figlio innocente – un ragazzo noto per avere sempre vissuto lontano dalle violenze, un semplice amante del calcio, vittima di follia criminale - vuol dire che un’intera città sta provando a rimettere nell’ordine giusto le cose, a cominciare dalle più sacre e più vere, dalla vita e dalla morte. E sta mostrando che quest’opera di riparazione è possibile ovunque ed è urgente in tutto il Paese.
Per questa straordinaria pagina di civiltà dobbiamo tutti ringraziare una mamma e una famiglia esemplari che si sono sapute fare guida di una città e esempio per l’Italia. Lo hanno fatto usando ogni volta le parole giuste con equilibrio miracoloso. Lo hanno fatto facendo appello alla parte migliore di ciascuno di noi, per riunire proprio la comunità nazionale, ben oltre le appartenenze calcistiche e i campanili, ben oltre i palazzi di Scampia e la città di Napoli, ben oltre lo stesso amore per il pallone. E quando le persone più colpite, dopo una terribile agonia e una morte così tragica, nel mezzo di un dolore che si fa fatica anche solo a nominare, sanno ricorrere alla propria più profonda spiritualità e a uno spirito repubblicano in senso vero e, da cittadini della Repubblica con una qualità etica fuori dal comune, fanno appello alla pace e ci riescono, vuol dire che la riparazione civile, in questo nostro caro Paese, è possibile.
Questa riparazione – alla quale ieri siamo stati chiamati - riguarda molte cose. E – sia chiaro - comporta metterci tutti in discussione, affrontare la fatica positiva di interrogarsi su quel che conta e quel che non conta, su ciò che è bene e ciò che è male. Vuol dire lavoro con se stessi e con gli altri, ascolto reciproco, costanza nel mettere da parte le distruttività che ognuno di noi ha e inventare, raccogliere, costruire speranze.
Questa riparazione non è fatta di parole ma di atti che vanno, appunto, pazientemente messi insieme, uno dopo l’altro.
Il primo di questi atti riguarda la giustizia per Ciro. Se la famiglia di Ciro e una città intera hanno rifiutato ogni parola di vendetta, a maggior ragione la giustizia deve sapersi esprimere nel modo più credibile possibile. La Procura di Roma deve fare bene e presto il suo lavoro, senza ombre e impunità, di alcun tipo.
In secondo luogo va ricostruita – perché non accada mai più – la catena evidente di errori nella gestione di una giornata che non doveva proprio finire così. Da tale ricostruzione vanno, poi, tratte delle conclusioni circa le responsabilità.
Ma è tempo di più profondi mutamenti. Ognuno di noi conosce decine di ragazzi che amano il calcio, che non sono violenti, che si accalorano per la propria squadra ma che non si nutrono di odio contro gli altri per cercare una propria identità. Sono ragazzi dei quartieri protetti e di quelli esclusi, che durante la settimana studiano, lavorano, provano, con vere difficoltà, a trovare le vie per farcela in un momento nel quale non è semplice crescere e costruirsi un futuro; e amano, coltivano amicizie e curiosità infinite per il mondo. Questi ragazzi vanno allo stadio perché vivono la passione ludica per il calcio, che è, in tutto il pianeta, la cosa che unisce più persone, la più grande metafora, comune a tutti, delle meravigliose complessità della vita. E per questi milioni di ragazzi, così come per gli adulti, vi è il sacrosanto diritto di raggiungere lo stadio, sedersi, divertirsi e tornare sani e salvi a casa.
Va finalmente ripristinato un sistema di limiti e di patti che permetta questo.
Le autorità che non sanno garantire neanche le condizioni elementari perché ciò avvenga vanno sostituite. I sistemi di sanzione per le squadre i cui tifosi vanno oltre ogni presidio del limite civile –con l’istigazione alla violenza e il razzismo o con gli atti violenti – deve prevedere una penalizzazione nella posizione in classifica. Alle frange fanatiche e violente di ogni tifoseria va impedito di controllare biglietti e ingressi, di recarsi allo stadio in modo militare, di condizionare il tifo sano in modo intollerabile. Le società di calcio, dopo questo funerale, devono sapere fare un gesto chiaro, scindendo ogni connivenza con quanto non è più accettabile. E anche il giornalismo sportivo deve sapere presto dismettere toni, lessico, costruzioni mentali che nutrono alibi per le violenze.
E, poi, i capi o i rappresentanti delle tifoserie devono mettersi finalmente in discussione e ripristinare dei patti di onore, fondati sul reciproco rispetto. In ogni ambito umano si formano delle leadership. Quando, però, questi leader portano verso il disastro devono trasformarsi, cambiando radicalmente rotta o essere costretti a farlo. A Roma il 3 maggio scorso – va pur detto – sono stati valicati, da parte di una minoranza fanatica, due ulteriori limiti rispetto a ogni tradizione del tifo: è stato cercato lo scontro fisico da parte di una tifoseria di una squadra che non era in campo quella sera ed è stata usata un’arma da fuoco in una rissa tra tifoserie.
Ebbene: quando, nelle dinamiche anche conflittuali tra i gruppi umani, si valicano i limiti simbolici ed insieme, concretamente fattuali che questi stessi gruppi si sono implicitamente dati lungo il tempo, secondo codici reciprocamente riconosciuti, è giunto il momento di ritornare presto a un nuovo patto generale, esplicito, costruito in un luogo simbolico e sulla concorde adesione, un patto di pace capace di avere un’autorevolezza tale da isolare per sempre chi non sa aderire a una nuova più ragionevole maniera di confrontarsi intorno a una comune passione.
E’ questo che devono fare le tifoserie oggi o essere costrette a fare.
Gli adulti che sanno camminare per i quartieri delle città, che fanno gli educatori nelle scuole, nei centri sportivi, nelle parrocchie e che ascoltano i ragazzi sanno che questo è il tempo per ripristinare un presidio dei limiti e anche un onore perduto. Il calcio affianca ogni giorno tutte le attività di milioni di ragazzi e ne plasma e accompagna le idee e le difficoltà, le speranze e le possibilità. La questione calcistica non è – dal punto di vista educativo – una questione come le altre ma in qualche modo le comprende tutte, proprio per la sua potenza metaforica e la sua universalità.
Perciò è tempo di girare davvero pagina.
E, dopo lo straordinario funerale di Scampia, la città di Napoli, che ama la sua squadra, è chiamata a riprendere una posizione nazionale della quale si è dimostrata all’altezza ieri e perciò – proprio nel nome di Ciro e della sua famiglia – a proporre a ogni tifoseria d’Italia una stagione di pacificazione e di vera riparazione civile.
Iscriviti a:
Post (Atom)


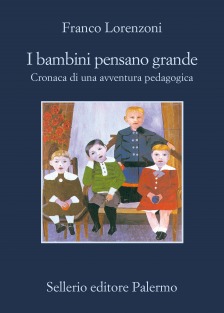

.jpg)
